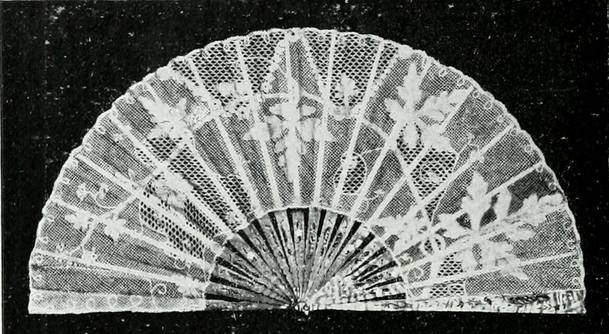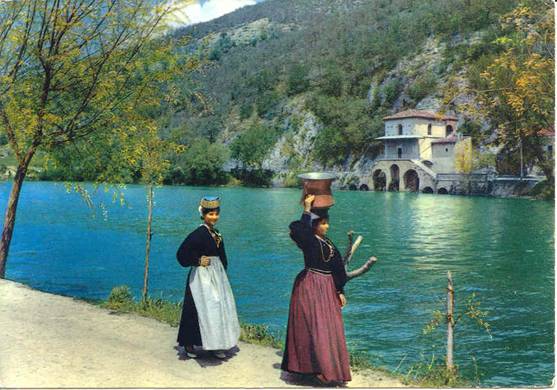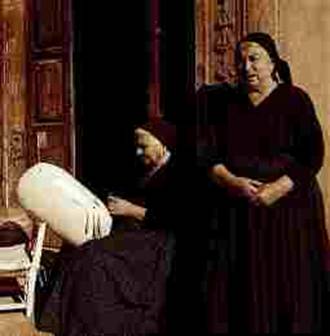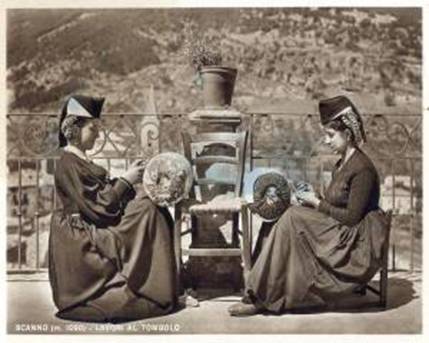|
Abruzzo
Costume
tradizionale di Mascione, (AQ) Estella Canziani,
La lavorazione della trina a fusello è
praticata ancora oggi su tutto il territorio abruzzese, i centri dove questa
arte è più diffusa sono L'Aquila, Scanno, Pescocostanzo.
Si presume che questa forma artigianale si sia diffusa in questi paesi perché
le donne, durante i mesi invernali non essendo impegnate nelle attività
di campagna, si dedicassero al tombolo. Questo le portò a perfezionarsi
nella tecnica e nell'avere ordinazioni di corredi tanto da farne un lavoro.
Il merletto abruzzese ritenuto prezioso e raffinato, acquistò fama e
prestigio in tutto il Regno di Napoli.
L'Aquila “Quando
Nella “Guida della città
dell'Aquila” datata 1888, Matilde Oddo Bonafede fotografava dettagliatamente la situazione del
merletto: “In molte città d’Italia v’ha
qualche lavoro speciale, dal quale le donne del popolo traggono il
sostentamento e qualche volta sensibili guadagni. In Palermo il ricamo, in
Firenze la treccia di paglia, in Venezia i lavori da conterie, nelle città
lombarde la filatura e la tessitura della seta e del cotone. Nell’Aquila il
lavoro tradizionale è il merletto. Fiorentissimo una volta, anche oggi
resiste alla concorrenza, e tiene alto il suo nome nelle industrie abruzzesi.
Si può dire che poche sono le donne aquilane che non siano pratiche in questo
genere di lavoro. Il così detto punto d’Aquila varia di prezzo secondo la
finezza del filo e l’altezza del merletto. Le coroncine e i ventaglini sono generalmente lavorati dalle bambine, perchè facili, e si vendono da 4 a 6 soldi al metro, se
lavorati in cotone grosso, da 8 a 10, in filo. L’altezza massima dei merletti
di punto aquilano è di centimetri 30, ed il prezzo massimo è di L. 250 al
metro. Ma nelle scuole elementari come in qualunque altro istituto femminile
di pubblica beneficenza, le bambine imparano anche il merletto Riattaccato, i
punti Guipure, Brusselles, Valencienne, Veneziano
ed anche il tanto pregiato e diffìcile punto
d’Inghilterra, che si vende fino a L. 1000 al metro. Le figlie del popolo col
guadagno di questo lavoro aiutano la famiglia; le signorine lavorano per
conto proprio e si preparano i loro corredi. Le forestiere, che amano il
lavoro, frequentano la scuola privata di merletti, e so di alcune giovanette
che, lasciando l’Aquila, portarono seco per molte migliaia di lire di questi
pregiati lavori fatti colle proprie mani. Il metodo adoperato per insegnare a
fare i merletti è semplice, e ad onore della gente aquilana debbo dire che
essa non è punto gelosa, come altre, della sua specialità, ma volentieri e
con disinteresse l’insegna a chiunque voglia apprenderla.” La Scuola privata di
merletto si trovava in Piazza S.Maria di Paganica, Palazzo Franchi e nel 1888
era ancora attiva.
Merletto a punto antico,
eseguito all’Aquila per
Guarnitura
di camice in punto aquilano riattaccato, appartenente alla marchesa Cappelli, mostra di Chieti 1895 Nel 1895, in
occasione di una visita della coppia reale all’Aquila, il quotidiano “Il
Popolo Romano” pubblicava questo accurato e dettagliato articolo: “ L’esposizione dei merletti Le LL. MM. Il
Re e la Regina, prima di lasciare Aquila, hanno voluto onorare della loro
augusta presenza un’esposizione di merletti aquilani, organizzata da un
comitato di signore presieduto dal marchese Dragonetti. Il Comitato era
composto delle più distinte e nobili dame della città, quali donna Anna Ciolina, marchesa Maria Cappelli, donna Rosa Palitti, marchesa Quinai,
marchesa Dragonetti, signora Ranieri, signora Grossi. Né, credo, potevano
meglio onorarsi le LL. MM. che invitandole a
visitare che ciò di più bello e pregevole produce la città nostra. L
‘industria del merletto sia all’ago che a fuselli è in Aquila una delle più
fiorenti. Il merletto aquilano segna un mezzo termine tra il vaporoso
merletto francese e il grandioso e nobile punto di Venezia. S.M. la regina,
da quella fine e intelligente conoscitrice che ella è, si è trattenuta
lungamente ad esaminare i numerosi merletti esposti, manifestando di tanto in
tanto la sua alta soddisfazione per la finitezza dei lavori che cadevano
sotto i suoi augusti sguardi. Nella sezione delle scuole comunali femminili
diretta dalla valentissima maestra pannicelli e dall’infaticabile cav. Parrozzani vi erano ventiquattro graziosissime bambine in
abito Bleu-ciel, intente
al lavoro dei merletti a fuselli, e con le quali S.M. la regina si è
lungamente trattenuta, rivolgendo una parola amabile e gentile a tutte.
Dovrei parlare dei lavori esposti, ma ardua è l’inpresa
in mezzo a tanta quantità e splendore di oggetti. Mi proverò alla meglio: Signorina Ciolina. Un
magnifico ventaglio ornato, e fazzoletto di pizzo aquilano Signorina Betti: uno splendido ombrellino a punto
attaccato, fazzoletto punto a fiori. Signora e Signorina Ranieri: vari squisiti merletti a
tutte coppie. Signorina Sidoni: pizzi a
fiori e ricami Signorina Ida Fabrizi: un meraviglioso merletto a punto
riattaccato. Signora Camerini: merletti in punto aquilano. Marchesa Dragonetti: punto d’Inghilterra. Signorina Bice Visconti: ventaglio in punto da ricamo. Donna Rosa Palitti: mouchoir in punto riattaccato Donna Bice Signorini: merletto a tutte coppie
ammiratissimo Destarono la generale approvazione i lavori dell’asilo
d’infanzia, scuole di S Paolo e delle signorine Mariangeli,
Visca, De Mattheis,
Paolini e molte molte altre. S.M. la regina e il
re, nel lasciare l’esposizione espressero nuovamente la loro piena
compiacenza per la riuscitissima mostra, ringraziandone vivamente il Comitato
organizzatore. Tutte le signorine esponenti erano presenti alla visita reale,
e formavano un vago bouquet di fiori. Fra gli uomini presenti, ho notato il
conte Guglielmo vinci, l’on. Galletti, l’on Cappelli Il senatore Cappelli il
cav. Ciolina e il nostro egregio sindaco cav. Jacobucci che tanto pure si è adoperato per la buona
riuscita della mostra. Un ringraziamento va pure al sig. Baiocco, che ha
ceduto per la circostanza la sua splendida sala, ove non si sa se più
ammirare la ricchezza dei marmi o il valore degli affreschi che la adornano.”
Sala
Baiocco L'Esposizione
Universale del 1911 a Roma prevedeva una mostra regionale ed etnografica
allestita nella odierna Piazza Mazzini. Luigi Serra, su questa mostra scrisse
un articolo dedicato al merletto aquilano sulla rivista Emporium:
“ La Mostra etnografica di Roma ha
offerto sin dal giorno inaugurale considerevoli manifestazioni artistiche al
pubblico eletto che girava per i viali non bene assodati e dove gran parte
dei padiglioni erano ancor cinti da impalcature. Fra le più importanti, sia perchè non evocazione faticosa, sia per l’intrinseco suo
accento di gentilezza, è quella dei merletti aquilani. Essi sono stati
accolti nella sala superiore di una casetta assai nota ad Aquila sotto il
nome di «Le Cancelle», che rispecchia il tipo delle
abitazioni popolari aquilane del secolo XVI, con botteghe sottostanti,
respirando, pur nella sua rozzezza, quel senso di eleganza che fu diffuso nel
meraviglioso periodo della nostra Rinascita per tutta la penisola. Il
merletto aquilano non è stato ancora indagato nell'intera sua significazione,
nelle origini, nelle rispondenze ideali con espressioni affini, nelle sue
peculiarità e ne' suoi valori con quella larghezza che esige la lunga
tradizione e la grande bellezza. Pare che il suo nascimento abbia a cercarsi
nel merletto veneziano, poiché con Venezia Aquila ebbe frequenti contatti
commerciali. Però il merletto aquilano assunse ben presto caratteristiche
spiccate. Ora esso è distinto segnatamente in merletto a punto aquilano
antico e a punto nuovo aquilano (Per questi cenni ci siamo largamente giovati
dello scritto del prof. Orazio d'Angelo in Illustrazione Abruzzese e della
conferenza della signorina Pia Catalano pubblicata nella Città dell' Aquila
del 30 aprile 1911).
La differenza tra codeste estrinsecazioni è definita
lucidamente dal d'Angelo, del quale riportiamo le parole: «Il punto aquilano antico
è eseguito con tutte e sette le combinazioni fondamentali del merletto, ad
eccezione della riattaccatura con l'uncinetto e lo
spillo, della quale non ha bisogno, e somiglia al punto d'Inghilterra, ma ha
reti speciali e di più ha rilievi di disegno, e le reti ed i rilievi si
lavorano contemporaneamente al tessuto, il che, mentre accresce le difficoltà
dell'esecuzione, conferisce al merletto maggiore finezza e colorito, ed una
elegante originalità. La direzione dei fili del tessuto di questo punto antico
è somigliante a quella dei fili di una stoffa ritagliata, applicata sul
tulle, ed il tulle si esegue diagonalmente. Occorrono moltissimi fuselli. Il
punto nuovo aquilano o commerciale, è eseguito su carta bucherellata con tre
delle sette combinazioni fondamentali, cioè col mezzo punto, il punto a tela
ed il fondo a rete, del quale ultimo si usano principalmente quello a conocchiola (maglie esagonali contornate da piccoli fori)
e quello a pizzi. I fuselli restano sempre, come nel punto antico,
raccomandati al tombolo, e così l'esecuzione ne riesce più facile, e maggiore
ne è la precisione. Altra caratteristica del merletto aquilano è che esso è
tutto di un pezzo, a differenza di quello veneziano e di quello valenciennes;
il filo è di finezza e bianchezza incomparabile. Il merletto ebbe grande
sviluppo ad Aquila nel Cinquecento e nel Seicento. Ma, quando sembrava
negletto, veniva coltivato nel silenzio dei chiostri come un vago fiore
alimentato nel mistero delle serre.
Sciarpa
e balza a punto Aquilano Soltanto ai nostri tempi l'armoniosa sua grazia si è
novellamente affermata in libero rifiorimento. L'impulso pare sia venuto
dagli ingenti acquisti di antichi merletti che molti mercanti forestieri
compirono. In realtà, va riconosciuto a due aquilane, Concetta Pannicelli e
Concetta Cerulli, il merito di aver fatto trionfare
su dall'abbandono secolare questa gloria locale e di averla mirabilmente
divulgata. Nei 1877 venne aggiunta alle scuole elementari femminili una
sezione di merletti. Dal 1899 il merletto si lavora nelle scuole
professionali femminili. E molte
onorificenze, conseguite in esposizioni italiane e straniere, attestano la
saviezza d'intenti che alla scuola presiede. Con le scuole professionali
divide il vanto della rinnovata espansione del merletto aquilano il
laboratorio L'Aquila. Esso sorse nel 1904, per iniziativa del commendatore
Vincenzo Camerini, uomo di intuito pronto e di alacri spiriti, un comitato di
dieci signore, cui presiedono con infaticata tenacia
Giuseppina Camerini, Binetta Bruno e Checchina Visconti, ha, in breve ora, impressa una vita
magnifica alla nascente istituzione, consacrata, si può dire, dalle insigni
onorificenze conquistate a Milano nel 1906, a Jesi nel 1910, e specialmente
alla grande Esposizione di Bruxelles del 1910.
A questo laboratorio appartengono i saggi che animano
le candide pareti della casetta aquilana trapiantata a Roma; che le scuole
professionali hanno inviata l'opera loro alla Mostra di Torino. Nella modesta
casa aquilana, da squisite mani disposti, rifulgono le pure forme in
atteggiamenti di grazia. Ecco una coperta di pizzi a fuselli, eseguita in tre
anni circa di intenso lavoro. Essa accoglie i motivi essenziali del pizzo
aquilano : i cappelli, le rosette, i quattro cuori o cuori doppi, il motivo
dell'angolo, quello dell’esse. Il disegno si deve al direttore artistico e
professor cavaliere GaetanoTentarelli, che ha spesa
la sua fervida attività nel comporre fini disegni per merletti. A tradurlo in
atto furon necessari circa 8.000 fuselli,
maneggiati da cinque operaie contemporaneamente. Accanto a questa si fa
notare una sciarpa lunga m. 2,80 e larga 70 cm. Anche per essa il disegno fu
fornito dal Tentarelli, il quale innestò con gusto
ai motivi consueti della Rinascita, altri di fantasia. L'agile delicata
compagine è opera della signorina Patrignani
direttrice del laboratorio, la quale vi si dedicò ben tre anni, adoperando
quasi 2000 fuselli. A volte i merletti ripetono motivi colti nei pili
cospicui monumenti che Aquila vanti. Tra essi va segnalato il leggero e
florido partito ornamentale che anima l'urna di Maria Pereyra
nel Mausoleo eretto a lei ed alla sua figlioletta da Silvestro dell'Aquila.
Altre volte si han variazioni sugli atteggiamenti tradizionali del merletto,
più o meno libere, ma sempre sobrie ed improntate di distinzione. Così in un
servizio da tavola per thè, con bordo fiorito di
freschi girari vegetali, con il centro
graziosamente trapunto, e vaghi effetti di linee e di chiaroscuro nei piccoli
tovaglioli. Così in una coperta, cui gli ornati geometrici infondono una
singolare animazione; in un merletto sontuoso per ricco motivo
insistentemente ripetuto; in alcuni ventagli di decoro intimamente diverso
l'uno dall'altro, nei quali la fantasia del disegnatore ha fermato armonie di
linee e leggiadrie di forme. Oltre questi esemplari, che esprimono almaggior grado l'alta venustà dei merletti aquilani,
molti altri si addensano; lavori di gran lena e di gran costo accanto ad
altri che han richiesto operosità minore e sono, perciò, più facilmente
accessibili. Così che questa esposizione, in cui sorride il più gentile fiore
della odierna attività artistica di Aquila, è insieme un omaggio al
continuato splendore della tradizione e come un augurale auspicio per
l'avvenire. Ed è dolce cosa poter intravedere in essa un accenno a quel
rifiorire del gusto artistico in tutte le espressioni della vita che già fu
precipua gioia del Rinascimento, del più radioso momento della nostra storia
civile.
Coperta
a punto riattaccato
Ventagli
in merletto aquilano Soft Art: una ricetta per
l’antica arte del merletto
|
|
“Il gioiello del tombolo” di Federica
Silvani e Francesco Rotolo unendo l’arte del tombolo e l’arte orafa hanno
creato una considerevole collezione di gioielli. |
Merlettaie di Scanno
Presso l'Asilo Comunale gestito da Suore,
alcune volontarie organizzano dei corsi, per poter tramandare l'arte. A
Scanno si trova "Il Museo della Lana" dove si possono vedere
reperti delle lavorazioni artigianali del passato, tra cui il tombolo. Molto
bello è il costume tradizionale che
non a caso viene nominato come "Il Costume degno di una Regina". Un
giovane imprenditore scannese ha realizzato delle
statuine in oro e argento che rappresentano la donna di Scanno nel
costume tradizionale.
Il costume tradizionale di
Scanno (tratto da “Poliorama pittoresco”, 1855-56)
“Il Signor Giuseppe Tanturri
di Scanno, nell’occuparsi della monografia di quel circondario che deve far
parte del Regno delle due Sicilie descritto e
illustrato, ci ha gentilmente inviato un disegno a colore del bizzarro
costume delle donne di quel paese, e da esso il valoroso Signor Mattej ha tratto la graziosa vignetta che accompagna
questo articolo.

Le donne di Scanno indossano panni di lana in
qualsivoglia stagione. La gonnella, che forse non impropriamente chiamano
casacca, è di colore verde cupo, scarlatto negli sponsali, con fitte pieghe
al di dietro, che raccolte e congiunte ad un pezzo di panno a foggia di
camiciola, tolgono a chi la indossa ogni garbo di vita; la quale perciò non
rimane quasi per nulla spezzata. Il giustacuore, “comodino”, diviso dalla
gonnella, è di panno turchino scuro, a larghe maniche pieghettate sulla
spalla e ne’ polsi, e guarnite di ricamo colorato nell’estremità; nel di
dietro ha piccola faldina sporgente ad uso di coda;
nel davanti chiude esso il petto quasi sino al collo; ma nuovo e bizzarro è
il modo di stringerlo ed abbottonarlo. Divisa la lunghezza delle due faldine in tre parti, nella prima parte superiore sono
quattro bottoni di argento disposti verticalmente che le chiudono; nel mezzo
sono altri sei bottoni disposti in due ordini su piccolo pezzo quadrilatero
di panno intagliato, che chiamano “pettiglia”; e
nella parte inferiore vengon chiuse con quattro “ciappette” anche di argento; le quali in certo modo
stanno a sostegno della non piccola dovizie del petto. Nel giro del collo il
comodino è guarnito di merletto increspato. Il grembiule, denominato “mantesa”, suol’essere di
tessuto di lana non gualcato (infeltrito), e di colore o scarlatto, o
cremisi, o cenerino, o violetto. Dividono i capelli dal sincipite
all’occipite in due porzioni, che accolgono posteriormente in due ciocche; le
quali intrecciate con lacci di seta di varii
colori, girano sul capo, a mo’ di corona, lasciando dietro le orecchie due
trecce con bel garbo disposte a semicerchio, le quali solamente sono
visibili, mentre il rimanente resta più o meno coperto da un originalissimo
“cappelletto”. E’ il “cappelletto” una specie di turbante, che diversifica da
quello de’ Musulmani perchè di poco più alto, con
coda più lunga, per nulla increspato nel davanti, ed è amovibile senza che
resti scomposto. La “tocca” , il “fasciatoio”, e il violetto ne sono i
componenti. La “tocca” è una fascia di bambagia a più pieghe, alta mezzo
palmo circa, che si avvolge dalla fronte all’occipite e da questo a quella, e
costituisce, direi quasi, l’ossatura del “cappelletto”. Il “fasciatoio” è un
pezzo di merinos, ovvero di tessuto di lana non
gualcato, di colore turchino oscuro, della forma di un’asciugamani, la cui
metà spiegano sul vertice, nel mentre adattano il lembo destro sul sinistro,
e l’estremità anteriore rovesciano sulla posteriore, facendo rimanere dalla
fronte in su un quadrilatero più o meno allo; e quindi col piegare il lembo
sinistro sul destro, arrotondano gli angoli anteriori, e ritengono con spille
nel di dietro all’orlo superiore della tocca le due parli ristrette, che
vanno cosi a cader penzoloni fin presso alla regione infrascapolare.
E’ questa l’“incappatura”, che corrisponderebbe
alla piccola tenuta, o tenuta giornaliera. Ma l’incappatura,
non è il cappelletto. Per aversi questo bello e formato, occorre il
“violetto”, cioè una seconda fascia di bambagia, ma grezza e di lento tessuto
la quale coi suoi giri , mentre copre perfettamente la prima, ed in parte
anche il “fasciatoio” lascia nel suo ultimo giro delle liste verticali
intessute di seta a varii colori, ed anche a
filigrana. Le calzette sono o bianche, o color cece, o turchine; e non
raramente veggonsi le scarpe guernite
di fibbie d argento. Sopraccaricano poi il collo di lacci di oro a maglie
sottilissime, dai quali scendono due, tre e talvolta quattro ciondoli, anche
di oro, chiamati “gioie” che fissano lateralmente alla “pettiglia”,
a guisa di altrettante insegne cavalleresche. Usano pendenti più o meno
grandi alle orecchie, una quantità di anelli con castoni ben grandi alle
mani. Le altre particolarità di questo veramente bizzarro costume, con talune
considerazioni, si leggeranno nel Regno delle Due Sicilie
scritto e illustrato.”

Vedova
e sposa di Scanno, Estella Canziani
Pescocostanzo,
Aquila
|
Merlettaie di Pescocostanzo che
lavorano all’aperto in Via Colle di S. Maria delle Grazie* |
Casa
del 1500 con giovane merlettaia al Largo Casale dell’Oca*
|
A Pescocostanzo,
tra il 1400 e il 1700, si stabilì una colonia di artigiani proveniente dalla
Lombardia, che influenzò le varie espressioni artistiche della città,
quindi anche il merletto ricevette una certa influenza nella sua
realizzazione.
|
Merletti
e ricami di Pescocostanzo, mostra di Chieti, 1895 |
Costumi
indossati, proprietà Colecchi |

Angolo ingrandito
del grembiule che compare per intero nelle due fotografie precedenti. Il
bordo interno è ricamato a fili contati, quello esterno è un merletto a tombolo
realizzato con fili colorati.
Corrado Ricci
nel 1905, descrivendo la casa della famiglia Colecchi
di Pescocostanzo scriveva: “La casa Colecchi è tutto un museo di
costumi, di tappeti e di merletti. Il suo salone è meno armonico di quello
dell'altro, ma è certo ugualmente ricco. Una decorazione di carta dipinta
vela il soffitto, portiere stemmate e dipinte celano le porte, tappeti
secolari ammantano i tavoli, sedie e sedili seicenteschi s'allineano intorno,
cornici e specchi occhieggiano. E se negli spazi vuoti s'ergessero delle
vetrine e in queste riapparissero in piena luce i costumi goldoniani
dei ricchi e quelli assai più originali del popolo minuto, le coperte
intessute di merletti fantasiosi, la camicia cinquecentesca fiorita con Vago,
il grembiule dalle roselline bianche e quello dai leoni rossi, il merletto
della «pupa”, dell'aquila e del garofano. Se la nobile casa facesse degna
mostra di tutto il suo tesoro celato nelle antiche casse col profumo dello
spigonardo, Pescocostanzo sarebbe fiera del più
squisito museo d'arte femminile dell'Italia meridionale. E i forestieri che
venissero quassù, comodamente in ferrovia fino a questi 1395 metri, non
sarebbero turbati dal rimpianto di un'abilità smarrita. Il gusto della bellezza
sopravvive con quello dell'alfabeto. Una confraternita insegna a leggere
italiano e latino a quelli che non sanno ed esercita quelli che non vogliono
dimenticare, un vecchio fabbro aspetta sempre ordini munifici per emulare con
successo i suoi maggiori, una maestra ha ritrovato il segreto della tessitura
doppia e delle erbe colorifere dei tappeti antichi
folti di bestiole, tutti i contadini diventano d'inverno marmorari, e tutte
le donne intessono gioielli di trine intorno al tombolo in ogni stagione. Il
costume delle buone donne, festoso di bianco rosso e turchino, ricco di trine
d'oro e di pizzi più preziosi ancora, è svanito col sopraggiungere della
fatica. La roncola e la scure, il fascio di legna e il sacco di fieno hanno
soppresso violentemente ogni ornamento, ogni lembo superfluo. Ma le piccole
mani ferite dal gelo e incallite dalla fatica non han perduto l'agile segreto
del ritmo dei fuselli; gli occhi nerissimi non hanno dimenticato la visione
sicura dei delicati nodi che inseguono le forme antiche. In ogni casa, ad
ogni porta, su ogni scala, accanto alla colonnina stemmata e fiorita che
canta la sua perenne armonia, v'è sempre una figurina intenta alla memoria
del modello prediletto, con un tombolo irto di punte sulle sue ginocchia, e
le rapidissime dita che ripetono il ritmo quasi inconsapevoli... Oh, miracolo
di un sentimento sviluppato fino ai confini dell' istinto! L'arte del
merletto prospera incontaminata a Pescocostanzo da
parecchi secoli. Il popolo e i dotti del luogo unirono sempre il primo
ricordo di quella abilità rustica con l'immagine della poetessa sconsolata,
con la graziosa signoria di Vittoria Colonna. E perchè
i Colonna ebbero continui rapporti con Venezia, e perchè
parve che una parte notevole del merletto antico ricordasse il punto e il
disegno veneziano, fu generale persuasione che Venezia e Vittoria Colonna
avessero trasportate fra le nostre montagne la delicatissima arte. Ma la
intuizione immediata della signora Elisa Ricci
che ne vide gli esemplari più celebrati assicurò che non soltanto l'influenza
veneziana ma su tutto quella milanese vi aveva avuto larghissima parte. E
tale giudizio trasse ben presto motivo di conferma da un pubblico istrumento
dell'anno 1566 scovato dal dott. Gaetano Sabbatini,
in cui si ricorda a Pesco, quale capitano amministratore di giustizia, un Giovan Battista Bagatti,
milanese. Ora è certo, che sia per le donne del
capitano, sia per qualche monaca capitata di lassù, il punto milanese fu
importato accanto a quello veneziano, sì che dell'uno e dell'altro tipo
restano esemplari stupendi, sì che del doppio motivo dura perenne la
conoscenza diffusa e l'abilità perfetta. La marchesa De Viti de Marco fa
giungere il refe d'Irlanda, monsignor D’Eramo
organizza il lavoro, una maestra ne tiene scuola, le Industrie femminili
italiane regolano lo smercio dell'abbondante produzione, e la squisita
industria rifiorisce. Dopo la fatica rude del bosco, l'agile lavorìo del tombolo è un ristoro!... Il bosco è lontani),
le montagne più vicine sono brulle, ma per contrasto i due piani che sì
diffondono ai lati del paese come due immense ali. sono tinti del più fresco
e più intenso verde. Scendendo verso la ferrovia e guardando la sterminata
pianura dal Colle Elisa, pare di vedere la distesa di un lago verde ondulato
dalle correnti e limitato dalla catena delle Pietre Cernare
frastagliate e irte come dolomiti. La Alajella
domina lontano questo spettacolo vasto e limpido della solitudine e della
ferrovia, del piano e della montagna, del prato raso e del bosco scuro, dell'
ingenuità primitiva e delle arti sottili...”.
|
Pescocostanzo, Casa Colecchi,
Largo della Fontana |
Sala
di casa Colecchi |
L’industria del merletto è tradizionale
nell’ Abruzzo.





Campionario
di merletti abruzzesi raccolto da Etta de Viti de
Marco e Minnie Luck, pubblicato su “Emporium”, 1895
Romualdo Pantini (abruzzese) nel 1895 scrisse un articolo molto
esaustivo sul merletto di Pescocostanzo sulla
rivista Emporium: “Vi fu un tempo, sempre quel beato secolo XV, in cui i merletti aquilani
gareggiavano con quelli di Venezia e di Genova. Ora tornano all’onore del
mondo per l’operosità animatrice della marchesa Etta
De Viti De Marco, e l’approvazione e l’incoraggiamento delle nostre Regine ne
hanno ratificato l’ottimo successo. A mille e trecento metri sul mare, in uno
dei più vaghi altipiani erbosi della Majella, Pescocostanzo conserva immutati il suo carattere e la sua
solitudine, nonostante che il fischio della locomotiva — languidetto
anzi che no — sibili alle sue falde e l’importanza climatica della vicina Roccaraso cominci a spingervi dentro noiosi e
sfaccendati. Pescocostanzo godè della protezione
illuminata di Vittoria Colonna. Per cura di lei, nobile signora e poetessa,
alcuni artisti pescolani poterono recarsi a Roma
per apprendervi a scolpire; e l’altare di marmo nella chiesa è testimonio
della loro bravura. Ora il motto nello scudo del Municipio suona fieramente:
«Peschus Costantius Utilis sui Domina»! Poiché sotto Ferdinando III gli
alpestri e fieri pescolani vollero soppresso
qualunque vestigio della loro servile sudditanza a’ Marchesi di Pescara. Del
resto, oltre l’altare marmoreo, tutta la chiesa dagli archi a pieno sesto
rifatta integralmente nel 1456, e il cancello in ferro battuto su cui nel
secolo XVIII ignoto artista indigeno riuscì quasi a cesellare capricciosi
intrecci di forme umane e mostruose, aggiungono vaghissimo interesse alle
povere case del paesello montanino. La forza maschile ne emigrò attratta da
altri soli, e le donne sono rimaste a sostenere insieme il lavoro della zappa
e del merletto. Vi sono come piccoli gruppi di famiglie che lavorano insieme,
ma indipendentemente e le fanciulle seguono un corso quasi regolare
d’insegnamento. Un tempo vi si praticava anche il punto ad ago, ma le
condizioni dure della vita hanno ridotte le donne al solo tombolo. Ed alcune
eseguiscono i merletti senza disegno di guida, semplicemente a memoria; e
questi merletti perciò detti a disegno sciolto sono stati molto incoraggiati
da una signora inglese, romana di elezione e di dimora, Miss Minnie Luck. Cosi la marchesa De Viti come la signora Luck hanno scoperto e rilevato il fascino di questi
merletti, visitando nella stagione bella il paese e dimorandovi per qualche
tempo. Monsignore d’Eramo, pescolano
di nascita, fu specialmente gentile nel facilitar loro le relazioni dirette
con le trinaje, le quali, per quanto fiere e amanti
della loro indipendenza in modo tutto abruzzese, riconoscono in certo modo
l’autorità della maestra elementare ed abilissima esecutrice, la signora Rosa
Tellis. La marchesa De Viti non poteva meglio
illuminare sul Giornale d’Italia la poesia e il sapore di questo lavoro
montanino, che era prima coltivato largamente nei vicini paeselli di Roccaraso e Rivisondoli. È
prezzo dell’opera riferire le sue buone parole: « Nel recinto di quelle case
dove il lungo freddo dell’inverno dà alla vita l’impronta d’una specie di
clausura, carattere che non perde nè pure durante
la breve estate, si trovano ancora donne industriose, umili, le quali,
uscendo raramente di casa, vivono in un mondo a parte, fatto tutto di lavoro
e dei problemi della tecnica, vi studiano per trovare nuovi punti,
s’ingegnano a ritrarre da frammenti di carta custoditi in qualche cassone, i
disegni tracciati da mani da lunghi anni sparite, e dove spesso una idea è
appena accennata e per indovinarla ci vuole l’affinità del sentimento
artistico con chi prima sognò quelle figure. Per quegli animi rinchiusi in un
silenzio medievale il tombolo offre quasi l’unico sfogo della fantasia e del
sentimento religioso. Quanti sogni ricordati in questi merletti! Qui studiano
il vero ed il bello, e nei lavori destinati alla chiesa ritraggono con cuore
devoto i simboli amati, li studiano, li penetrano animandoli di fervore
mistico». E veramente se grande è l’interesse artistico e la squisitezza
tecnica di queste trine, fatte per fiorire le gale fruscianti di una gonna
come per punteggiare lo scollo bruno di un seno vergine, o per decorare la
santità dell’altare d’amore, molto deriva dall’affetto con cui quelle donne
continuano il lavoro tradizionale delle loro famiglie. E questo amore è
sentito. Alla marchesa De Viti una contadina diceva nel suo rozzo dialetto
che un merletto o un tessuto è inutile senza l’affetto con cui è stato
lavorato. E chi ricordi anche vagamente le idee sane del Ruskin sulla bellezza
del lavoro manuale, non può non essere sorpreso dalla mirabile corrispondenza
di pensiero a tante miglia di distanza.
Pinti Pinti
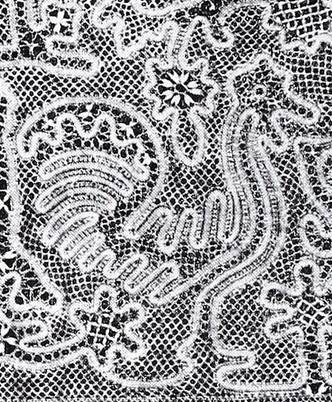

Campionario
di punti e motivi
Questo
modo di dire abruzzese così grazioso ed incisivo si traduce semplicemente in
italiano: punti punti. E mi piace prendere da essi
le mosse, perchè danno quasi l’immagine immediata
degli umili merletti a fusello che le contadine di Pescocostanzo
hanno rimesso in onore. I pinti pinti
non rappresentano ancora i frisi più minuti. C’è la filettera
che è il semplice filo riunito col fusello; ci sono i denti di cane che
rasentano il più semplice ed embrionale smerlo. I pinti
pinti sarebbero tuttavia il friso più ingenuo, ma
organico: sono infatti costituiti da una serie parallela di anelli, smerlati
di qua e di là. Queste piccole trine a nastro sono le più dilette alle
contadine abruzzesi, perchè non impediscono loro di
attendere alla vigilanza de’ bambini e delle pecore. Le fanno non altrimenti
che la calza o una trina, all’uncinetto; non altrimenti che le contadine
toscane cianciano e cianciano senza fine intrecciando la paglia. Giustamente
la signora Romanelli lo notò nel suo manuale. Le
contadine abruzzesi hanno tolto al tombolo — sempre s’intende per le piccole
trine il suo aspetto fastidioso, ingombrante, diciamolo pure coercitivo. Ne
hanno ridotto le proporzioni, ne hanno foggiato una tal sorta di rozzo
manicotto che legato al collo per mezzo di un cordone non impedisce i liberi
movimenti delle braccia. Naturalmente bisogna che tengano i fuselli dalla
parte anteriore; e se l’effetto è strano, è anche ammirevole la pazienza e
l’alacrità con cui conducono il lavoro storcendo un poco le mani. Immagini
della natura e della vita sono accolte largamente a foggiare i motivi
emblematici dei più semplici frisi. Naturalmente la interpretazione è un po’
vaga, secondo la esperienza e l’abilità della trinaia.
In certi casi confesso sinceramente che senza la spiegazione esplicita mi
sarei stillato inutilmente gli occhi ed il cervello, ad indovinare il senso
recondito degli amorosi intrecci. Così nel friso dei pescitelle
si avrebbe un bel riguardare per comprendere in quelle piccole losanghe la
forma tipica del pesce. Pur sono pesciolini e ci gusta che lo spirito
inventivo delle lavoratrici abbia congiunto un motivo essenzialmente
geometrico con questa forma naturale. Geometriche sono certamente le minime e
compatte serie delle crocette, ma in questi lavori minori la chiusadotte emerge per vaghezza ed armonia. Otto fili
chiudono (di qui il nome del merletto) il vaghissimo friso che anche ad un
occhio inesperto rivela un sobrio equilibrio di parti. Passiamo a frisi più complessi. La stranezza degli appellativi
è certamente stuzzicante. Guardate un po’ la mezza scaletta, la scaluccia, il vasarello:
sorprendente è la seggetella. Le dà nome quello
scherzo fanciullesco che si fa incrociando quattro mani. Da questo piano di
diti intessuti — che altrove in Abruzzo si chiama, più enfaticamente, seggiolina d’oro — all’abbozzo del merletto il trapasso è
forte. E si sarebbe tentati di pensare alla clepsidra,
se in un friso troppo classicamente non si ricordasse il simbolo della
cornucopia. Più pronta corrispondenza stilistica è nelle tre frondette con risvolta, nella frondetta
appesa colla rete, nei piccoli cuori posati fra le anse di un nastro. Anche
l’antica monetina del regno borbonico, il carlinello,
appare in piccoli gruppi, a tre, distinti fra loro o raccostati. Ma più di
tutti la «sonata sul tamburello » deve riempirci di stupore. Questa
rappresentazione grafica della musica potrebbe prestarsi a molte divagazioni.
Ma nel capriccio del disegno che riunisce alla meglio due motivi distinti,
due tempi, è forse riposta la ragione del nome capriccioso.

Tovaglietta
con pupazzi
Pizzi maggiori.
L’elemento
figurativo desunto direttamente dalla vita, più o meno armonizzato bene su
alcuni prototipi geometrici della consuetudine, è stato del tutto trascurato dai
trattatisti. Forse essi Io ignoravano affatto. Ma pei merletti abruzzesi
questo elemento è di una importanza originale, se non assoluta: è la stessa
vita nei suoi aspetti giornalieri, che si rispecchia nel lavoro, che
s'immedesima con l’arte, e in essa si spiritualizza. A considerare lungamente
queste figure embrionali che persistono anche nelle trine di maggior lena e
sviluppo, nei merletti cioè che rivelano maggiore studio di disegno e una più
facile trasformazione a contatto di merletti e disegni facilmente importati,
pare di cogliere nel loro ritmo un po’ incerto, la stessa armonia di uno
stornello o di una cantilena locale. Guardate in un elegantissimo fregio per
fazzoletto come la figura umana sia costretta nelle valve sferiche, e sia
proprio ridotta alla sua essenza primitiva. Ora per intendere meglio la
presenza ed il nome di questi pupazzi, bisogna ricordare che ogni buona
contadina abruzzese, come anche altrove in campagna, forma con la pasta una
tal sorta di figuro che fa cuocere nel forno e regala ai bambini.



Il
gallo o l'uccello domestico in genere è un’altra figura che ricorre sovente.
E tiene il campo quasi assoluto nel merletto secentistico, con l’occhio
stellato come un fiore, con la cresta crociforme, con le ali e la coda
largamente stilizzate; ed appare in forma più ridotta e cincischiata, con la
coda trasformata addirittura in un fiore astrale nel grandissimo fregio
(certo per tovaglia d’altare) in cui è frammesso e connesso ad un largo e
barocco motivo di tralcio.
Ma il motivo essenzialmente
floreale, oltreché in questi saggi confusamente, è di una bellezza vaghissima
in altri merletti e specialmente in uno molto composto quasi classico e però
riferibile senza dubbio alla seconda metà del cinquecento. Benché molto meno felice
non si può trascurare un qualche spunto architettonico. Nel largo pizzo
riprodotto insieme col precedente si ripete una serie di tre simboli senza
alcuna connessione stilistica fra loro. Il modello del tempietto greco-romano
é evidentissimo; non così chiari si possono dire gli altri due, forse una
croce ortodossa e la rilegatura di un breviario. E una decorazione allestita
alla meglio da qualche disegnatore locale, forse per suggerimenti ricevuti,
certo per decorazione di arredi sacri.
Tra il punto napoletano ed il punto di
Genova.
Gli
studi amorosi della signora Romanelli mi dispensano dalla noia e dall’aridità di
un esame tecnico e stilistico insieme. E’ evidente da uno sguardo complessivo
delle splendide riproduzioni che una originalità completa non si può
riconoscere. Piuttosto bisogna dire che le industriose e pazienti lavoratrici
hanno saputo ravvivare e far proprie molte trine di classica nomea. Fra i
loro merletti ricorre sovente il pizzo rinascimento e il punto Duchesse. Ma è
strano che nessuna infiltrazione vi si noti dei tre punti veneziani. E qui
bisogna riflettere che il paese di Pescocostanzo è
del versante occidentale della Majella, quindi
fuori di quel contatto immediato che Ve¬nezia pur
ebbe commercialmente ed industrialmente col litorale abruzzese. Lasciamo ai
trattatisti del genere che districhino tutte le sottili classificazioni; per
noi hanno valore assoluto così i più eleganti e geometrici pizzi, come quelli
in cui la mano rustica pare ancora inceppata nella estrinsecazione di
un'idea. Certo le caratteristiche più notevoli di questi merletti sono da
ricercare nella simbologia degli oggetti domestici ed in certe
rappresentazioni della flora e della fauna. Esclusa ogni derivazione
veneziana, il campo delle osservazioni per lo studioso si restringe tra il
punto napoletano ed il punto genovese. Anzi, poiché il Séguin
e la stessa Romanelli convengono che il punto
napoletano non sia che una derivazione genovese, noi forse dobbiamo a’ soli
modelli liguri quella esattezza e delicatezza geometrica, che possiamo dire
perfezionata in alcuni merletti per gala. La signora Romanelli
riporta nel suo manuale Hoepli una trina genovese (v. pag. 230) che il Séguin vorrebbe della prima
metà del seicento ed ella crede ancora cinquecentesca. Questa trina
difficilissima, disegnata sul tracciato di un reticello
ha un motivo fondamentale nella rosetta. L’andamento di questo guipure, come
anche un po’ di tracciato per l’esecuzione ad ago, noi ritroviamo nel
bellissimo pizzo. Solo le centine sono semicircolari ed il rapporto del
motivo a ventaglio è molto intimo col motivo onduleggiante
che sostiene la parte longitudinale del pizzo. A ogni modo questo mi sembra
degno di una speciale considerazione : è il più bello e il più vago fra i
merletti a fuselli che ricordan ancora lo spirito e
la leggerezza di quei pizzi ad ago, di cui forse la più miracolosa esemplificazione
è nel libro di Cesare Vecellio
veneziano.
La vecchierella.
In
questo risveglio salutare di arte femminile e rurale, quanta parte conta la
vecchierella! Ella è la figura simbolica della tradizione che invecchia ma
vuol essere raccolta o sostentata ancora: ella è come il lume esausto che dà
ancora gli ultimi guizzi, perchè siate a tempo di
riaccendervi la vostra lampana. Quando il
tristissimo inverno del 1872 rese persuase le signore venete che le isolane
di Burano e di Torcello
avevano bisogno di un lavoro assiduo, di una industria utile e bella per
campar la vita, il famoso « Punto di Venezia » non era conosciuto ed eseguito
che da una settuagenaria, da una povera rammendatora,
Cencia Scarpariola. Ed
era così rozza ed ignorante la povera donna che dovettero metterle intorno
qualche giovane perchè da quelle mani tremole sorprendesse il segreto e la tecnica del punto.
Più tragico è il caso recente di Valseriana.
Ottuagenaria era la vecchia che ancora vi praticava il « punto avorio » o «
saraceno ». Ma la contessa Suardi accorrendo sul
luogo contrastò alla morte il segreto di una bella industria femminile, che
ora, promossa e favorita, è di gran vantaggio al paese. La vecchietta, come
avesse compiuto ogni sua funzione di bene, poco dopo morì. A Pescocostanzo, dove le trine non sono l’assoluta
occupazione delle povere donne, anche ottantenne è la vecchia che conserva,
unica, la pratica degli antichi tappeti ricamati a mano.Ora
l’esperienza ci ha resi più solleciti e amorosi di questa arte rustica, che
adorna la nostra casa, che profuma la nostra vita e dà ristoro alle buone
lavoratrici; e però non tarderà molto che anche l’ottuagenaria di Pescocostanzo, la maestra dei tappeti, sarà ricordata con
le antiche vestali di Burano e di Valseriana.
L’avvenire.
L’avvenire
di Pescocostanzo ci può riservare molte e gradite
sensazioni; oltre l’industria dei tappeti, esso potrà ravvivare un genere più
nobile ed elegante nello stesso ramo dei merletti. Negli antichi esemplari
del 500 e 600 appaiono frange eseguite tutte co’
fuselli, ma in seta di diversi colori. Alcune sono state ritrovate dalla
benemerita Miss Luck; ed è sperabile che perle
ricche guarnizioni possano avere il più largo favore delle dame. Ma una cosa
occorre ancora: un rinnovamento bene inteso. Questa moda arcaica che prevale
in tutte le forme della vita accenna a decrescere, accenna cioè a diventare
veramente utile e vitale. Dalle forme antiche dobbiamo desumere il sano
insegnamento per le buone forme nuove. Cristallizzarsi nella copia arida
sarebbe mortifero. E le brave trinaje di Pesco
hanno sempre dimostrato uno spirito ed una ricerca continua di vivere la loro
vita di oggi insieme con la vita spirituale del passato. Utilissimo può
riuscire un sapiente innesto di forme nuove su le antiche trine, quando ci
sia uno spirito illuminato che sappia cogliere e interpretare il sentimento
regionale di questi merletti. Un semplice sguardo a quella mirabile « Corona
» di Cesare Vecellio basta a persuadere chiunque
che l’arte gentile delle trine è suscettibile di qualunque forma di bellezza
e di vita.”








Alcuni esemplari antichi di
trine pescolane, gli ultimi due esempi sono
eseguiti liberamente senza l’ausilio del disegno.
La trina pescolana è realizzata con filo di lino e sovente il
lavoro è a filo continuo. Si va da un minimo di sei coppie di fuselli per il
pizzo rinascimentale, ad un massimo di trenta per quello sciolto e i motivi
caratteristici sono : la giara, l'aquila, il pesce, la rosa.
|
“ I Pupi”, merletto del XVIII secolo*
( Collezione Fam. Colecchi, Pescocostanzo) |
“Le
Pupe”, particolare di un merletto del XVIX secolo, similare al precedente e
conservato al “Cleveland Museum of Art”,
Cleveland, Ohio, USA. Dono di |

Merletti
pescolani, collezione Fam. Sabatini
Per poter tramandare la tradizione alle
nuove generazioni il Comune di Pescocostanzo ha
istituito nel 1992, presso il Palazzo del Governatore, la "Scuola del
Merletto a tombolo", finanziata con una specifica legge regionale dove i
ragazzi possono seguire lezioni gratuite da giugno a settembre. Presso
Palazzo Fanzago, antico convento di clausura, è
ospitato il museo del merletto.

Merlettaia di Pescocostanzo in Via Del Corso



Alcuni sampler
del XVIII secolo
Sulmona, Aquila
Nel 1868 all’Esposizione artistico,
archeologico, industriale svoltasi a Genova, troviamo dei merletti a piombini di Sulmona portati
dalla marchesa Maddalena Crosa di Vergani.

Atri (Teramo)

Costume
tradizionale delle contadine di Atri^
Bonafede Matilde Oddo nel 1888 descriveva così il costume di Atri: « Le contadine di
Atri coprono il loro capo con largo fazzolo di
forma quadrata, ripiegato per diagonale e rimboccato nei due lati sopra la
testa. Un tempo fu di panno lino orlato di merletto o (pizzillo)
poscia si fece di percalla ricamato all’ intorno ed
oggi di tullo (tulle) ancor messo a ricami più o
meno ricchi. Gli orecchini (sciacquagli) sono
alcuni cerchietti di oro, poligoni più o meno grandi, ornati nel mezzo con
una catenella smaltala. La collana, o è di coralli ad un filo, a due e tre e
fino a quattro, l’uno più lungo dell’altro, cosicché stringono ed abbracciano
per intero il collo; oppure la collana può essere fatta di tante pallottoline di oro ( poste d’oro) anche a più di un
filo. L’apertura della camicia è orlata di merletto. Una specie di corsettino (sacchetto) stringe la vita ;questo ha maniche
spezzate, raggiunte da nocche di fettucce, e n’escon
fuori alcuni rigonfi della camicia appunto là sopra le spalle. Il grembiule (parnanza) per lo più è bianco. La gonna (guarnello) ha finissime pieghe dette codde,
ed è ornata nella parte inferiore con una balzana di fettuccia. Un tempo,
quando correva un’età sobria e pudica, il vestire delle nostre contadine era
per lo più di panno lano tinto in casa con iscorze di alberi e fiori campestri. Oggi appena si è
conservata la foggia di quel semplicissimo vestire; e spesso oggi fra le
genti del contado le meglio stanti, si usa la seta in luogo del modesto
fustagno.”
Canzano
(Teramo)
“Canzano, città
del merletto”, questa dicitura si trova in una targa posta all’ingresso del
paese, qui le donne sono orgogliose della loro scuola di ricamo e merletto
dove abili e sapienti insegnanti impartiscono la loro conoscenza.
Gessopalena (
Chieti)

Antico merletto prodotto
a Gessopalena





Merletti del XVIII secolo
eseguiti senza ausilio del disegno

Merletto attribuito a Gessopalena* (Campanari, Roma)
Guardiagrele (
Chieti)
Guardiagrele, alle falde della Majella, ha una sua storia legata soprattutto
all'artigianato e qui tutti gli anni, si svolge
In questo Comune, nasce nel 1998 l’Associazione “ Le
Arti Antiche”, con sede nell’ex convento delle Suore Francescane;
l’associazione ha come scopo principale, mantenere vivo l’interesse verso la
tradizione nazionale e abruzzese, del ricamo e del merletto.

Vasto (Chieti)
A Vasto, presso il Palazzo d'Avalos, ha sede una collezione prestigiosa di costumi
tradizionali. Possiamo ammirarne uno che rappresenta l'abito per le feste
importanti ed ha il grembiule impreziosito con merletti realizzati al tombolo
e così anche la "tovaglia" o "velo da testa".

Costume esposto nel Museo di
Vasto
Tocco da Casauria
( Pescara)
Mostra di merletti: Tocco,
merletti di inizio 800 alla cantina Filomusi Guelfi,
di Walter Teti
TOCCO DA CASAURIA - L'occasione del
concerto del duo Ciavatta-Ciolino che la sezione di
Pescara di Italia Nostra propone questa sera, alle ore 20.30, nella sede
della cantina dei Filomusi Guelfi di Tocco, dà
l'opportunità a Lorenzo Filomusi Guelfi, titolare
dell'omonima enoteca, di esporre al pubblico antichi merletti, pizzi, e trine
risalenti alla prima metà dell'Ottocento. La scelta di far svolgere il
concerto nella prestigiosa tenuta Guelfi rientra nell'ambito delle iniziative
per la valorizzazione del patrimonio architettonico storico regionale, che
Italia Nostra ha realizzato in collaborazione con il Conservatorio di musica
di Pescara "Luisa D'Annunzio". Scovati in due "stanze
morte" della immensa casa di famiglia di Popoli dalla moglie Amelia Genco, dove probabilmente sono rimasti sepolti per almeno
un secolo, i preziosi capolavori artigianali sono stati portati nell'antica
residenza dei nobili Filomusi Guelfi di Tocco,
«dove potranno fare bella mostra di sé sistemati vicino alle opere in legno e
in pietra che adornano la casa, anch'essa un gioiello di ricchezze storiche e
architettoniche», spiega la signora Amelia. «I reperti», precisa Lorenzo Filomusi Guelfi «costituivano i corredi di nozze di
nobildonne entrate nella nostra famiglia: è nostra intenzione condividere con
tutti l'apprezzamento di questi autentici capolavori». (Questo
articolo è apparso sul quotidiano “il Centro”, il 13 settembre 1998)
Penne, Pescara
A
Penne nell’ottocento alcune famiglie si erano dedicate alla produzione di
biancheria che veniva poi venduta nei mercati di Roma. Il ricamo, oltre la
pregevole tessitura degli arazzi, godeva di un’attenzione particolare e
quando si istituì nel 1887 l’Istituto d’Arte, una delle prime sezioni fu
quella del ricamo e merletto. Nella seconda metà del ‘900 la
scuola manteneva ancora questa sezione, infatti la Gazzetta Ufficiale del 6
giugno 1959 pubblicava il bando di concorso per 101 insegnanti di arte applicata
nelle scuole d’arte statali e per Penne si cercavano 2 insegnanti di merletto
e ricamo. Attualmente non si hanno notizie se il merletto abbia ancora una
sua continuità.

Negli anni ’50 era in circolazione questo
francobollo ”Il tombolo in Abruzzo e Molise”, del valore di 6 Lire.
1853 Mostra Industriale, Napoli
Nel maggio del 1853 si svolse a Napoli la mostra dei
prodotti dell’industria del regno di Napoli, all’epoca l’Abruzzo faceva parte
del regno e portò in esposizione una quantità considerevole di merletti. Vi
parteciparono la Real Casa De Medici per gli
Abruzzi, lo stabilimento delle scuole Pie di S. Paolo per l’istruzione delle
alunne povere, le scuole Pie di S. Giuseppe per l’istruzione delle donne
povere dell’Aquila, il conservatorio di S. Maria della Misericordia, il
conservatorio della SS. Annunziata dell’Aquila.

|
Onore
alle merlettaie di un tempo Leone Anna Anna viene citata nell’ “Annuario del Ministero dell'Educazione
nazionale” del 1940 come maestra di laboratorio per trine e merletto presso
la “Regia Scuola Professionale Femminile”, P.zza San
Basilio. In quell’anno c’erano 51 alunne che frequentavano la scuola.
|
|
Maria Pasquetti Maria,
merlettaia per passione, ha insegnato anche alle giovani allieve nei
piccoli paesi aquilani tra cui Fonte Cerreto.
https://www.youtube.com/watch?v=6uxcTmq9jvU&t=3s Questo video di Antonio Giampaoli ricorda Maria Pasquetti
mancata nel 2016. |
Scuole, Associazioni, Musei
Museo
e scuola del merletto P.sso Palazzo Fanzago (Antico
convento di clausura) P.zza Municipio Pescocostanzo ( AQ) Tel.
0864-640003
"Museo della Lana "di Scanno Casa Comunale Via
Calata S.Antonio
Scanno (Aquila) tel. (IAT) 086474317
"Mostra annuale del Merletto e Ricamo" P.sso Palazzo De Bernardinis
Canzano
(Teramo) La
mostra si svolge nella prima quindicina di agosto
Mostra Regionale dell'artigianato artistico
tradizionale
L'Aquila 1-20
agosto
Mostra Artistica della Majella P.sso Edificio
Scolastico Via Cavalieri
Guardiagrele (Chieti) La mostra si svolge tutti gli anni dal 1 al
20 agosto, c'è anche un concorso a premi per ogni settore artistico.
info@artigianatomajella.it http://www.artigianatomajella.it/storia.htm
Videografia
https://www.youtube.com/watch?v=id8p03daPPM
https://filumroma.it/2024/03/11/filum-intervista-i-suoi-ospiti-m-cristina-bravi-e-il-suo-filo-doro/
Bibliografia
* Agostinoni
Emidio “Altipiani d'Abruzzo” di, 1912
Bonafede Matilde Oddo «Guida della
città dell'Aquila »,
1888
Modigliani Ettore, la foto del merletto per la regina Margherita è tratto da Exhibition of
Abruzzese Art at Chieti,. The Connoisseur, Vol. 14 (1906)
^ tratto da “ Poliorama
pittoresco”, 1836
#LEGGE
REGIONALE N. 29 del 03 04 1990 FONTE BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23 5 1990
N. 12
Ringraziamenti
Per la collaborazione si ringraziano i siti:
http://www.fondazionelions.org/sezioni/museo_costume.htm
www.isinet.it/abrunet/artigian/tombolo/tombolo.htm
http://www.abruzzoitalico.it/Paese.asp?ID=6&Paese=Scanno
http://www.sposavip.it/paesaggi.htm
http://www.wildflowersewingstudio.com/lace.htm
http://www.scannonline.it/artigianato/tombolo/home.asp
http://www.lartedeltombolo.it/index.html
https://archive.org/details/emporium3334berguoft/emporium3334berguoft/mode/1up
https://archive.org/details/emporium21isti/page/388/mode/2up
I
testi sono dell’autrice
E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione, anche parziale, di questa e di tutte le pagine del sito.