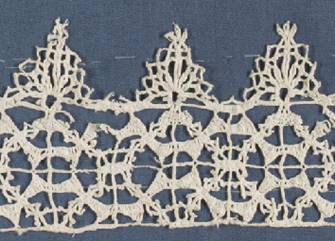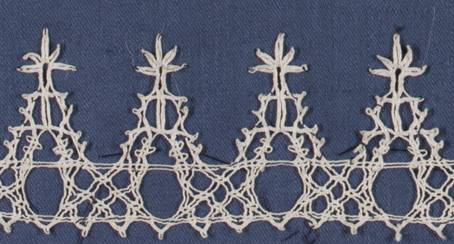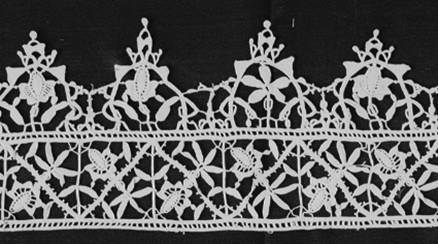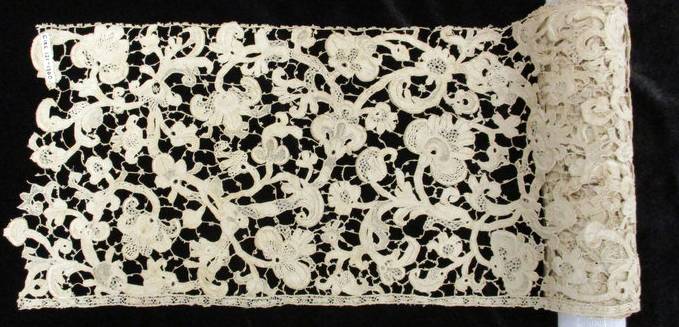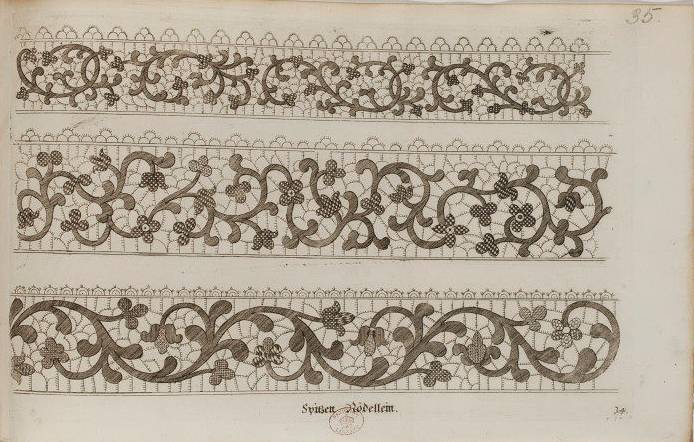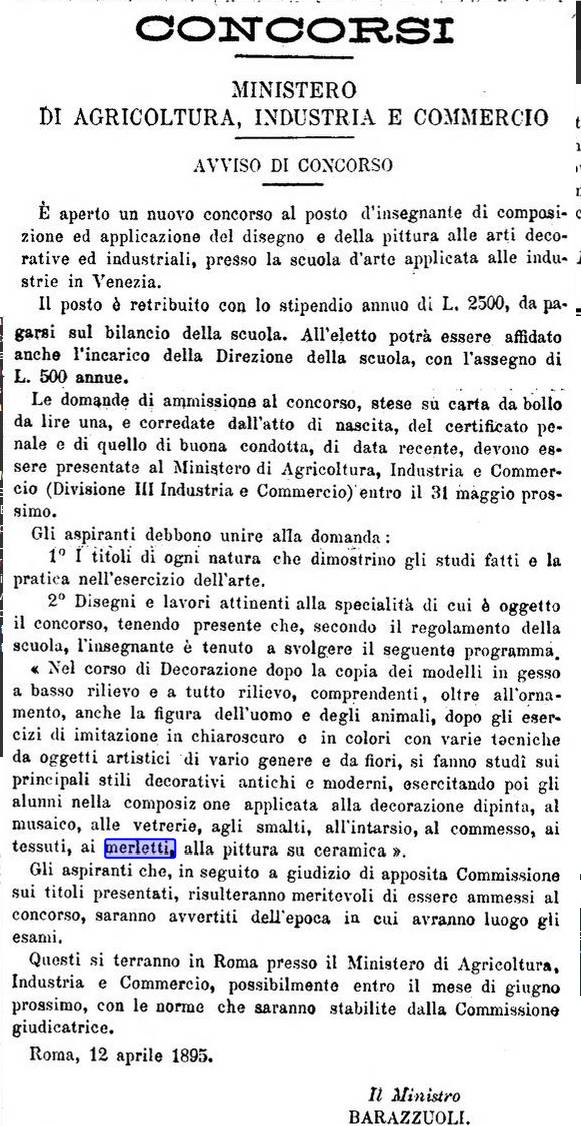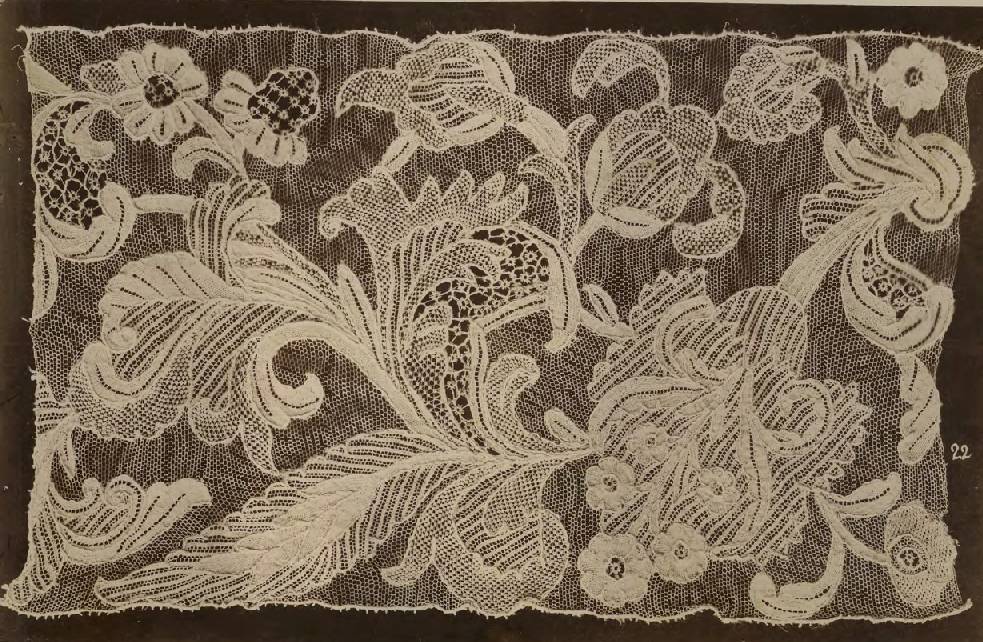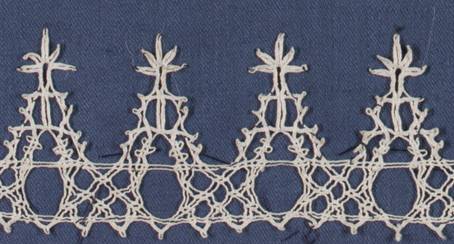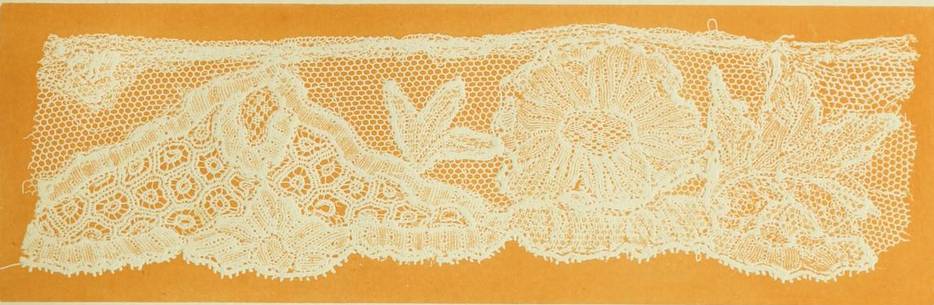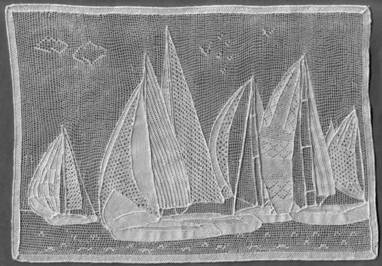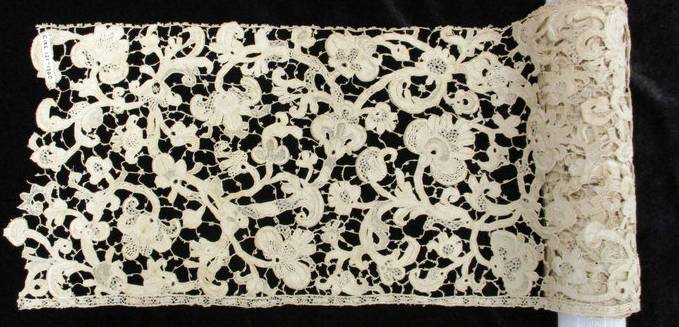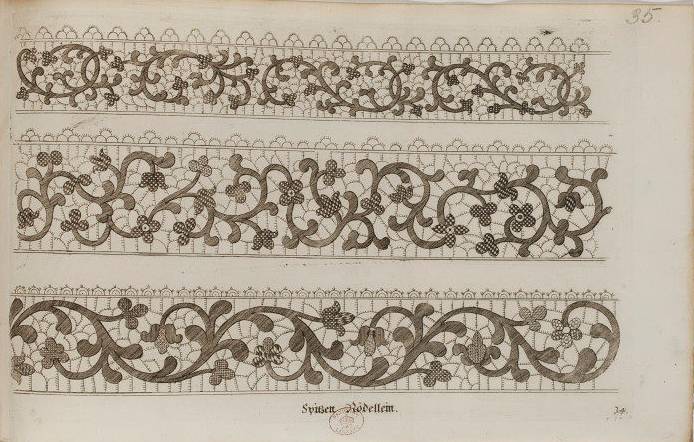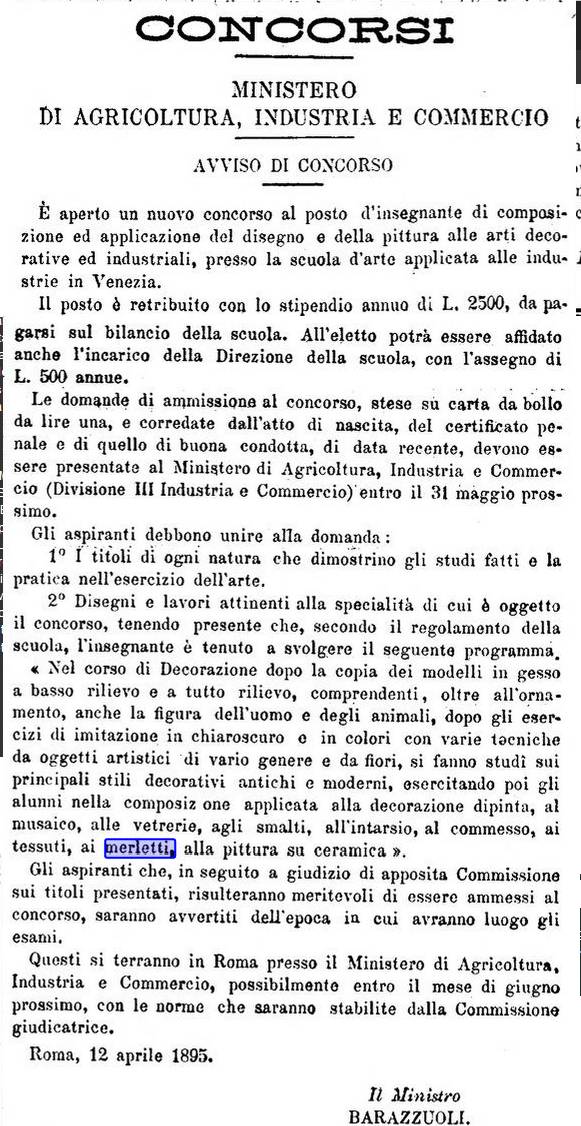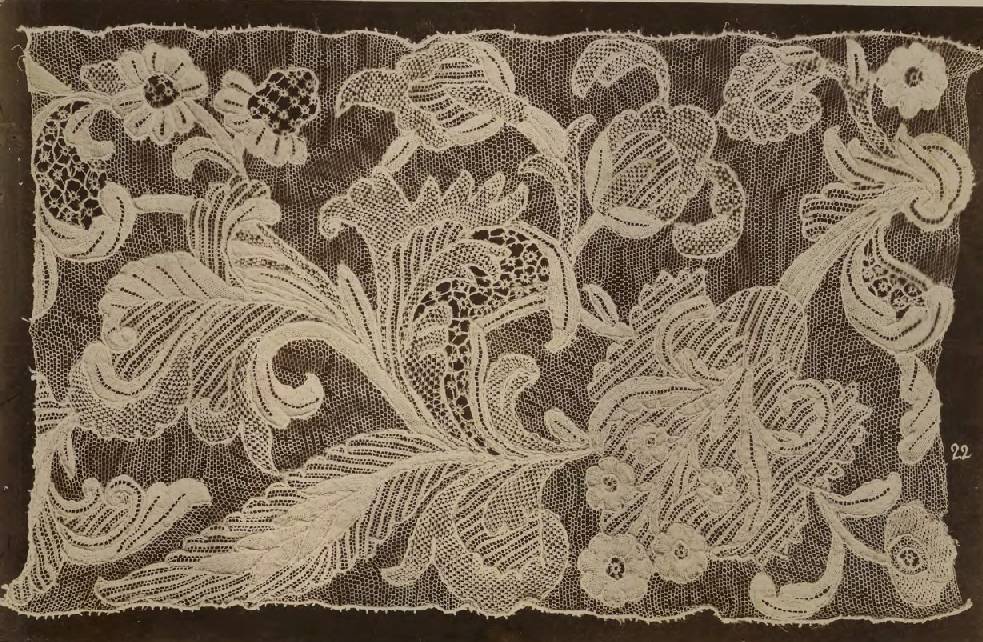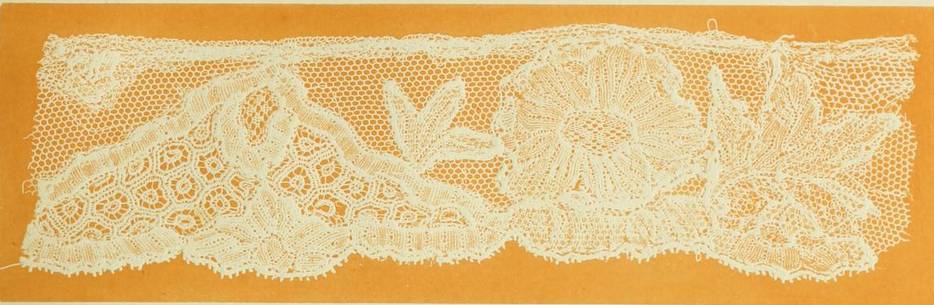Merletto veneziano ad ago, “Ponto in aere”
Storia
Il
vocabolo “merletto”*deriva dalla parola
merlo-merli, cioè le frastagliature che ornano le mura di cinta dei castelli medievali
e dagli elementi architettonici dei palazzi veneziani.
Le smerlature architettoniche della Cà
d’oro e Fontego dei tedeschi
Fontego dei turchi, Palazzo ducale, Venezia
Frammenti di merletti italiani realizzati ad ago, XVI
secolo
Punto
in aria, filato di lino, 1635 circa. Possiamo notare che questo esemplare,
eseguito in data successiva ai precedenti, ha perso la costruzione geometrica
del reticello. Il ricordo di trama e ordito che
serviva al primordiale ricamo, ha perso la sua costruzione. Il disegno è
libero con aggiunta di motivi floreali, i disegnatori dell’epoca si
ispirarono alla natura esotica e di altri mondi appena scoperti. Il
merletto ad ago è “il merletto per eccellenza”, per il suo valore artistico,
per il suo pregio e raffinatezza, queste componenti sono rimaste inalterate
nel tempo. Infatti, ancora oggi le merlettaie veneziane, pur rinnovandone la
foggia ed il disegno in una continua ricerca, mantengono la stessa tecnica di
esecuzione, realizzando i pregevoli merletti con gli stessi punti di 500 anni
fa.
"La Barcolana" , Luisa Severi Capo, filato cotone 40 e
100, disegnato ed eseguito nel 2000 Riccardo
d'Inghilterra (1452-1485) volle ornarsi di pizzi veneziani e ne fece
richiesta alla Serenissima. A questi tempi i pizzi a Venezia si appellavano gramite: “tre camixi
nuovi con le gramite zale
lavorate a san marcho (tre camicie nuove con
merletti gialli lavorati a San Marco)»^ Uno
dei primi documenti storici che ne attesta la presenza a Venezia, risale al
1476, data in cui venne emanata una legge
suntuaria che prevedeva pene severe per chi non limitava nel suo
abbigliamento, l’uso di merletti fatti ad ago e realizzati in oro o in
argento. La
tradizione popolare veneziana vorrebbe il merletto ad ago legato ad una leggenda oppure alla lavorazione delle
reti dei pescatori delle isole. Il
merletto ha iniziato a muovere i primi passi grazie alle donne nobili che
riuscirono a manifestare la loro sensibilità e creatività, creando dei
capolavori. C’è da ricordare che all’epoca, alle donne non era consentito
istruirsi, né leggere, ma solo dedicarsi al canto, alla danza e alla musica.
Alcune dogaresse, presero così a cuore l’arte del merletto, tanto da emettere
delle leggi protettive permettendo la continuità e lo sviluppo del “ponto in aere”. Fra
queste illustri dame ricordiamo: nel XV secolo Giovanna Dandolo moglie del doge Pasquale Malipiero,
Lidia Priuli Dandolo e nel XVI secolo Morosina Morosini, moglie del
doge Marino Grimani che fondò nel 1595 il primo laboratorio
di merletto, dando l’opportunità a decine di donne veneziane di tutte le età
di cimentarsi in un lavoro dignitoso e onesto. La
dogaressa Pisana Corner Mocenigo si presentò, in una sua visita ufficiale,
con un manto d'oro ed una sottana di pizzi d'oro con cintura di brillanti. A
testimonianza del piacere nel possedere preziosi merletti, sono rimasti a noi
documenti cartacei molto importanti. Al
1500 risalgono i primi modellari realizzati
da noti incisori dell’epoca e in quel periodo Venezia esportava già i suoi
preziosi manufatti.
Merletto ad ago di
Venezia a punto grosso, 1650-1700 circa © Victoria and
Albert Museum, Londra Le
cronache del XVII secolo raccontano che nel Campo S.Angelo
Raffaele, si affacciava la casa delle due maestre merlettaie Lucrezia e
Vittoria Torre le quali fecero un collare di capelli canuti, che fu pagato
250 ungheri, e servì al re di Francia Luigi XIV nel
solenne giorno della sua incoronazione. La casa si trova ancora oggi di
fronte alla Chiesa dell’Anzolo Rafael. Verso
il XVII secolo, Burano divenne l’isola dove le
merlettaie venivano sfruttate per produrre grosse quantità di merletti.
L’idea di portare il lavoro nelle isole, venne proprio dal fatto che gli
abitanti delle isole vivevano in povertà e avevano difficoltosi e costosi
contatti con la terraferma. Le donne dovevano solo lavorare accettando un
modestissimo compenso per il loro pregevole lavoro. Nel
1665 alcune merlettaie veneziane vennero chiamate dalla corte francese del re
Sole per insegnare la perfezione del merletto veneziano. In quello stesso
anno Luigi XIV annunciò l’apertura ufficiale della
“manifattura reale dei merli ” specializzata nei punti di Francia. Ma l’esito
impensato produsse un merletto ad ago francese con un suo stile ed un suo
disegno capace di competere con quello veneziano. Le merlettaie vennero
richiamate a Venezia dal Doge e in caso di mancata obbedienza sarebbe stata
emessa nei loro confronti, la pena di morte. Ben presto la Francia invase il
mercato europeo e Venezia proibì l’importazione ed il consumo di qualunque
merletto non proveniente dall’area Veneziana. A Venezia nel 1696,
l’ambasciatore di Francia M. De Bonzy vescovo di Bézier, scrisse al ministro Colbert che il convento di S. Zaccaria e tutti gli
altri conventi e le famiglie povere, vivevano dell’industria dei merletti.
Nei ricoveri veneziani per zitelle e fanciulle povere il lavoro era
regolamentato con estrema precisione in ogni ora di luce e fruttava alle
ragazze una piccola dote, detta ”la tasca”. Lo smercio della produzione di
pizzi era prerogativa esclusiva della superiora. Agli inizi del Settecento
l'industria dei merletti era già in declino. Nel 1734, nei negozi di merletti
veneziani, i merletti francesi, fiamminghi e inglesi venivano venduti a
prezzi più convenienti rispetto alla produzione locale. Il Melani nel 1892
scrisse: “Verso la meta del XVIII secolo alcune botteghe veneziane vendevano
per lo piu de’ pizzi esteri. Nel 1734 esistevano
ancora a Venezia i seguenti spacci de pizzi: al San Carlo, alle due Rose, al
Premio, al Bucintor Ducale, all’ Aquila d'oro, alla
Madonna degli Angeli, al Cardinal. Non pochi certamente e più che sufficienti
se in ognuno si fosse lavorato e venduto soltanto della produzione locale. Ma
invece, ovunque si appagava la taccagneria della gente, col vendere i pizzi
di Fiandra, di Francia, d' Inghilterra a miglior mercato dei veneziani.^
Nel 1821, il quasi dimenticato Antonio Retti, sostenuto da
Andrea Pitteri, Giuseppe d’Este e il dott. Pasqualigo, “con sommo dispendio e molta difficoltà, come
ricorda nel suo prezioso opuscoletto
sui Merli di Burano
il Pasqualigo, aveva in sé raccolto
d’intorno un buon numero di
lavoratrici e a Burano commissionava non
indifferenti quantità di punto in aria.
Per cui il brav’uomo ebbe anche dall’istituto di scienze lettere ed arti lombardo-veneto il premio di una medaglia”. E quel primo
prezioso seme di rinascente attività non andava perduto e Burano,
al contrario di quanto scrisse Bury Palliser nel suo Histoire de la dentelle, non aveva mai dimenticato la sua arte che
conservava con dignitosa fierezza, mantenendo fede alla fama del merletto
eseguito perfettamente. Il fuoco sembrava sopito, ma bruciava sotto la cenere
ed è bastata una piccola scintilla per far divampare la bellezza in tutto il
suo splendore. Paulo Fambri
e la Contessa Andriana
Marcello sono stati gli artefici della rinascita, con nobile slancio
infondevano nuova vita all’antica industria dei merletti a punto Burano e il Pasqualigo scriveva:
“Coll’accrescersi dell’attività femminile la moralità avanza a gran passi, il
benessere materiale non è più ignoto, la decenza, l’istruzione, la civiltà
non sono più lettera morta”. Contemporaneamente
nacque la manifattura Michelangelo Jesurum che aprì scuole a Venezia per il merletto ad
ago, Chioggia per il filet e Pellestrina per i fuselli. A
Venezia nel 1878, venne pubblicato un “Trattato storico tecnico della
fabbricazione dei merletti veneziani” dove si elencavano le diverse specie di
merletti fatti a Venezia: punto a reticello, punto in aria, punto tagliato a fogliami, punto a gruppi, punto a maglia
quadra, punto di Venezia, punto di Burano,
punto tirato, burato.
Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 1895-04-13 n.
088 Questo ci fa comprendere che tutti i
tasselli andavano al posto giusto: la raffinatezza dei gusti, la ricerca di
nuovi disegni, nuove idee, le maestranze pronte a capire che era il momento,
la generosità delle persone facoltose, la voglia di migliorare ed avere una
opportunità. La donna stava cambiando! Nonostante
le leggi suntuarie, le guerre e distruzioni, l’usura e tutte le avversità che
hanno colpito il merletto veneziano, oggi noi abbiamo in tutti i musei del
mondo il più grande patrimonio di merletti che le mani delle nostre ave ci
abbiano lasciato. Nel museo del merletto di Burano, troviamo testimonianze uniche e rare di
queste opere eseguite con tutto l’amore e dedizione, al quale va portato
tutto il nostro rispetto e riverenza. Tutta
l’Italia ha lavorato incessantemente per svariati secoli, silenziosamente per
guarnire prelati, regine, imperatori,
il loro abbigliamento e le loro case. Conosciamo i merletti perché li abbiamo
visti da bambini sulle foto dei libri di storia, poi da adulti nei quadri di
grandi pittori, forse non ci siamo mai chiesti quanto è lunga e faticosa la
storia del merletto.
Un
pregevole campione di merletto ad ago veneziano dove il decoro fluttua
morbidamente nella rete a “punto Burano” (tratto da
un campionario di merletti di Burano datato 1884).
Merletto di Burano con la
classica rete di fondo, apparso sul “Dizionario del ricamo”, 1890*
Pizzo
rituale ebraico in seta (parte di un insieme), Burano,
Inizio XVIII secolo. Donazione della signora George Nichols,
della collezione di sua madre, la signora. J.P.
Morgan (1868-1925), 1938. Considerando l’epoca della realizzazione, la foggia
del disegno è all’avanguardia e così anche l’esecuzione. Metropolitan
Museum of Art, New York. Il
museo possiede diversi merletti catalogati di provenienza dall’isola di Burano o dalla scuola di Burano. _____________________________________________________________________________________________________________ *merlo, merletto,
merluzzo, merlo o trina: una certa
fornitura o trina fatta di refe finissimo o d’oro o altro—Giglietto, dicesi a specie di trina
con merluzzi e punte così detta perché ha similitudini con il giglio—Bighero, fornitura fatta di filo a merluzzi
V: ponto de Buran.(
tratto dal vocabolario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio
,1829) Bibliografia
*“
Commemorali del Gradenigo” * The dictionary of needlework, Caulfeild, Sophia Frances Anne, Saward Blanche C ^
Melani Alfredo, l’Arte nell’industria, 1907 ^ Melani Alfredo,
Svaghi artistici femminili, 1892 La Famiglia e la vita
quotidiana in Europa dal '400 al '600
“L’Ateneo
Veneto”, rivista bimestrale, articolo di
Angela Nardo Cirele, 1898 I testi sono dell’autrice E’ vietata qualsiasi forma di
riproduzione, anche parziale, di questa e di tutte le pagine del sito. Furto di un
merletto a Burano 1909 https://archive.org/details/GV1911-10/page/n133/mode/2up?q=merletto+merletti+trine https://archive.org/details/GV1923-07/page/n93/mode/2up?q=+merletto+merletti+trine https://archive.org/details/GV1923-07/page/n107/mode/2up?q=merletto+merletti+trine https://archive.org/details/naturaedarterass1513unse/page/673/mode/1up?q=+pizzo+merletto |