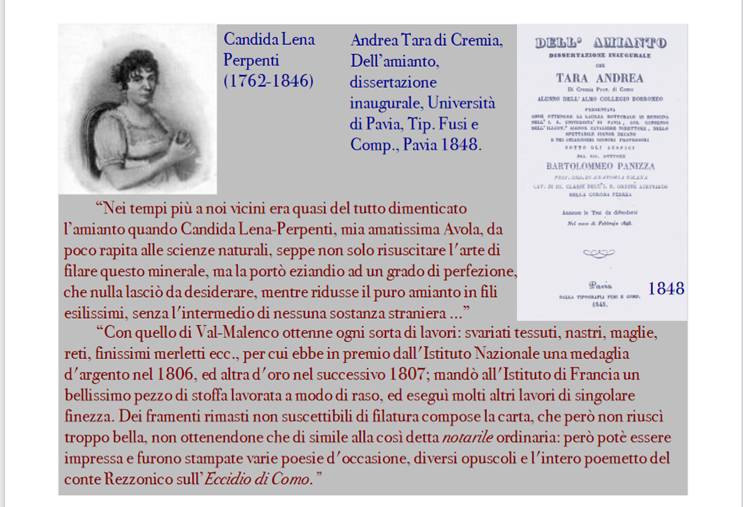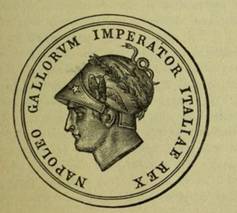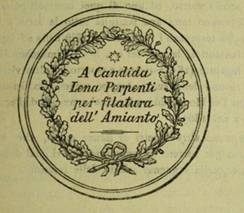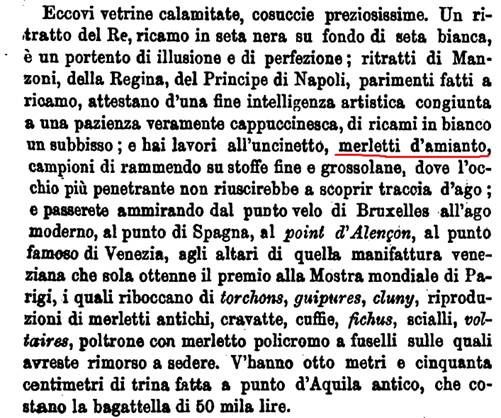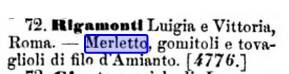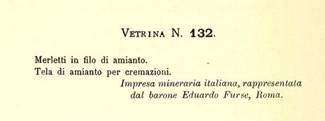|
Amianto
Fibra di amianto come si
presenta in natura In una pubblicazione del 1847
così si scriveva a proposito dell’amianto: ”Amianto — Avrete senza dubbio
inteso a parlare che gli antichi popoli bruciavano i cadaveri dei loro cari,
e ne conservavano le ceneri; ed avrete al tempo stesso pensato come mai era
loro possibile di separarne quelle ceneri dagli avanzi della combustione nei
roghi, che, come sapete, così chiamavansi quelle cataste di legna sopra cui
si ponevano ad ardere i cadaveri. Or bene sappiate che il mezzo per ciò
ottenere era d'involgere la spoglia dell'estinto in un lenzuolo di amianto,
che per nulla si altera all'azione violenta del fuoco. Vi parlerò dunque
brevemente di questo minerale, che è uno dei più singolari prodotti della
natura, composto principalmente di silice, di magnesia, di poca allumina e di
calce, cioè a dire degli elementi che formano le pietre più dure. La
disposizione delle sue molecole somiglia a quella dei vegetabili, e da ciò la
sua tessitura a fibre lunghe, lucide, simili a quelle della seta, e queste
facilmente si separano in fili estremamente sottili ed elastici, che lo fanno
paragonare al lino ed alla seta. Il suo colore è talvolta d'un bel bianco di
seta, tal altra grigio, verde, bruno, ed anche nero, le più belle varietà si
trovano nel Brasile, in Savoia ed in Corsica, ove si unisce ad una terra
argillosa per fabbricar vasi da cucina, meno soggetti a spezzarsi per la
violenza del fuoco e per gli urti. Un
antico lenzuolo fu trovato nel 1702, entro un'urna con delle ossa
avviluppate, due miglia fuori la porta Prenestina, oggi Maggiore, ed ora si
conserva tra le altre rarità nella gran sala della biblioteca Vaticana. La
sua grandezza è prodigiosa, poiché ha 5 piedi, 7 pollici e 7 linee e mezza di
lunghezza, e 4 piedi, 11 pollici e 9 linee e mezza di larghezza. Sul principio di questo secolo
Maria Domenica Fumasoni Biondi di Marino presentò all'accademia dei Lincei in
Roma alcuni bei lavori in amianto. In seguito altre persone industriose
filarono l'amianto, e l'unirono al cotone od al lino, e così il filo avea
maggior consistenza e lunghezza. Fattone il tessuto, lo gettavano al fuoco,
il quale consumando il cotone ed il lino, rimaneva il tessuto d'amianto puro.
Nel 1816 la sig. Lena Perpenti a Milano ne fabbricò tela, carta e merletti.
Un'opera stampata interamente in carta da essa fabbricala, fu deposta
all'istituto di Francia da Huzard. Ecco i metodi praticati dalla Perpenti.
Prese l'amianto flessibile che trovavasi nella valle di Malenco. Si lava
prima nell'acqua comune, asciugato che sia, si separa in piccoli mazzetti, si
stropiccia leggermente, e si stira in senso opposto, prendendolo per le due
estremità. A misura che le sue parti in tal guisa separansi l’un dall'altra,
si sviluppano molti fili bianchissimi, lunghi 5, 8 e sino 10 volte più del
pezzo di amianto dal quale provengono. Tale allungamento delle fila d'amianto
è un fenomeno assai curioso e straordinario, di cui i naturalisti non sembra
che abbiano per anco fatto menzione. Questa qualità di amianto presenta nella
sua forma soltanto fibre grossolane, e col metodo di stiramento indicato se
ne ottengono fila finissime, bianchissime, tanto lunghe da poterle usare in
ogni sorta di lavoro; trovatisi aggomitolate nelle sue fibre grossolane, come
i fili della seta nel bozzolo. Si staccano colle mani le fila che derivano
dai due frammenti di amianto, e si dispongono sopra un pettine formato da tre
ordini di aghi da cucire. Questi fili essendo lunghi, molto pieghevoli ed
assai fini, lavoratisi sul pettine colla maggiore facilità, allo stesso modo
del lino e della seta. L'amianto filato in tal guisa può servire ad ogni
sorta di lavori. La stessa operazione può eseguirsi sui pezzi rimanenti
quando abbiamo sufficiente lunghezza. Gli scarti possono ancora servire alla
fabbricazione della carta che si fa coi metodi medesimi, sostituendo
l'amianto agli stracci. Per rendere consistente la carta di amianto, le si dà
colla o gomma, sciogliendo l'una o l'altra di queste sostanze in sufficiente
quantità di acqua. Quindi vi si immerge una spugua, con cui percorresi
leggermente la superficie di ogni foglio, nella stessa guisa che si colora la
carta commune: quando è asciutta, cilindrasi per far sparire tutte le pieghe.
Il cav. Aldini di Milano stabilì in grande la tessitura e filatura
dell'amianto, e rese più semplice la fabbricazione della carta e cartoni. In
luogo della semplice lozione dell'acqua fredda, si valse del vapore di essa ;
in tal modo da qualche pezzo di amianto, minore di un decimetro ottenne fila
sottilissime quanto la seta, e lunghe più di un metro.
Nel 1865 in provincia di Torino
si cominciò la produzione industriale di carte e cartoni di amianto, poi dal
1882 di filati e tessuti a Grugliasco. Nella “Gazzetta ufficiale del
regno d’Italia” del 1881 in riferimento all’esposizione Nazionale di Milano
si cita testualmente:
Nel 1873 tra gli Atti ufficiali
della Esposizione Universale di Vienna del 1873, raccolti nel catalogo
generale degli espositori Italiani 1873 troviamo che la ditta Rigamonti
Luigia e Vittoria di Roma esponevano
merletto, gomitoli e tovaglioli di filo d’amianto.
Anche nell’esposizioni retrospettive e
contemporanee di industrie artistiche a Roma nel 1887 si sono visti merletti
in amianto.
Descrizione del contenuto della vetrina N. 132,
nella quale c’erano dei merletti in filo d’amianto. Nel
1909 la camera di commercio di Torino, pubblicò la statistica industriale del
distretto camerale nei circondari di Aosta, Ivrea, Pinerolo, Susa, Torino
(esclusa Torino città), Biella, Vercelli. Nei circondari di Torino all’epoca
si scrisse: “Sono diciassette gli stabilimenti diretti alla fabbrica di
tessuti dividerli per la rispettiva produzione speciale in quattro categorie:
lavorazione della juta, canapa, fibre miste, amianto. Complessivamente le
quattro categorie ora accennate danno impiego a 1960 operai, di cui 1300 donne
e 200 fanciulli. In rapporto ai quattro gruppi suddivisi si deve tosto
rilevare la preponderanza assunta in questa categoria d’industria dalla
fabbricazione dell’ amianto. L’industria della filatura e tessitura
dell’amianto merita una nota speciale, perchè essa è relativamente poco
conosciuta sia nella sua lavorazione come nei prodotti che essa provvede.
L’industria dell’amianto è coltivata in Italia, in Germania ed in Francia. In
Italia si lavora specialmente la qualità del Canadà, della Russia ed anche
per lavori inferiori quella del Piemonte, per lavori inferiori, diciamo,
perchè quest’ultima si presenta di poco rendimento, con una fibra corta, di
poca resistenza, di colore scuro, utilizzabile solo nel fare cartoni. La
materia prima è passata sotto macine, setacci e congegni diversi per
costituire la massa che è poi sottoposta a cardatura e filatura, mentre il
cascame e le fibre troppo corte per essere filati sono ridotti alla
fabbricazione di cartoni. Generalmente nella fìlatura l’amianto è mescolato
con cotone per accrescerne la potenzialità filabile e nella torcitura i fili
sono accoppiati a fili di ottone o ferro che restano nel centro del filo o
della corda. Oggi è largamente applicata la tela d’amianto nei teatri e nei
reparti industriali ove la combustione può essere facile. Nel 1906 il tribunale
di Torino giudicò ammissibile e credibile una denuncia di pericolosità per la
salute dell’amianto. Nel
1898 Adelaide Anderson e
Lucy Deane Ispettrici
del Lavoro in Gran Bretagna scrivevano nell’Annual Report
of the Lady Inspectors of Factories la
pericolosità delle polveri di amianto osservando che nelle fabbriche dove si producevano
tessuti e materiali contenenti amianto le operaie si ammalavano gravemente ai
polmoni. Nel
1906 Montague Murray
illustrò in Gran Bretagna, un caso “emblematico” di malattia da amianto
arrivato alla sua osservazione già sette anni prima sulla fibrosi polmonare, diffusa tra gli operai che
lavoravano a contatto con l’asbesto. Anche
in Francia lo stesso anno 50 casi di morti di tessitrici furono messe in
rapporto con l’esposizione a polveri di amianto; In Italia l’asbestosi fu riconosciuta una
malattia professionale nel 1943 (Legge n° 455 / 12 aprile 1943). Quando la tossicità
dell’asbesto e dell’amianto non era ancora nota all’opinione pubblica. Molti
“addetti ai lavori”, soprattutto imprenditori e manager delle aziende di
settore, erano edotti che «nell’Annual Report of the Lady Inspectors of
Factories” del 1898 Adelaide Anderson e Lucy Deane ne avevano osservato la dannosità. Bibliografia · “Processo
verbale della distribuzione de' premi (Regno d'Italia : Istituto nazionale
delle scienze e delle arti, 1808)”. ·
Pantheon di cognizioni utili ed
amene, artistic scientific letterarie utili a tutte le classi della societa,
1847 ·
Atti ufficiali, della
esposizione universale di Vienna del 1873. ·
Sangiuliani di Gualdana, conte
Antonio. Guida illustrativa del Civico Museo di Como in Palazzo Giovio,
1898 ·
Erculei Raffaele; Museo
artistico-industriale (Roma), Tessuti e merletti: esposizioni retrospettive e
contemporanee di industrie artistiche, esposizione del 1887 ·
Torino, Economia corporativa,
Consiglio provinciale, 1909 Statistica
delle industrie del distretto camerale .. Sitografia https://www.ibasecretariat.org/workshop-report-1898.pdf https://archive.org/details/guidaillustrativ1898cava/mode/2up?q=merletti |