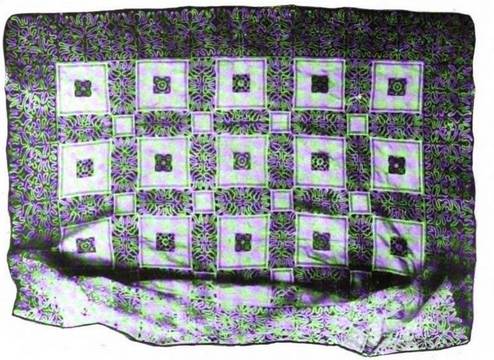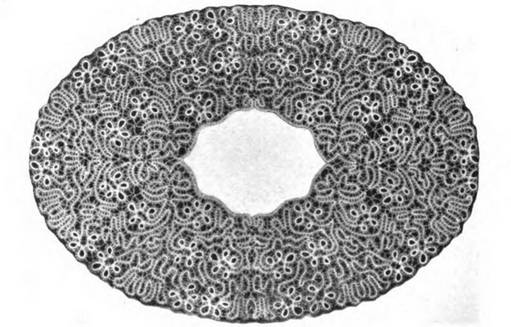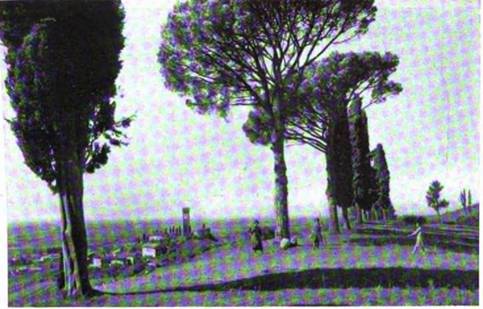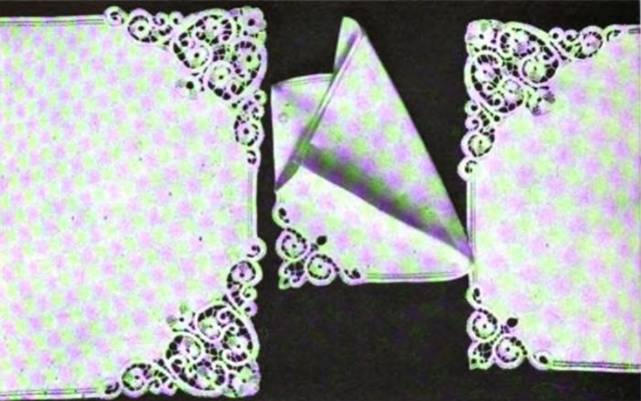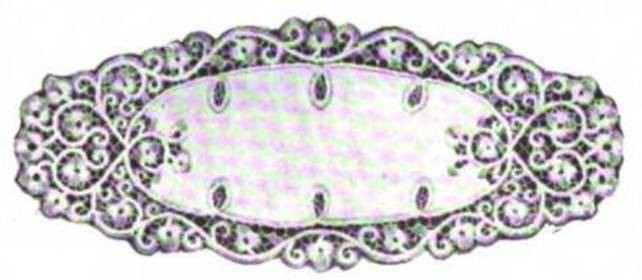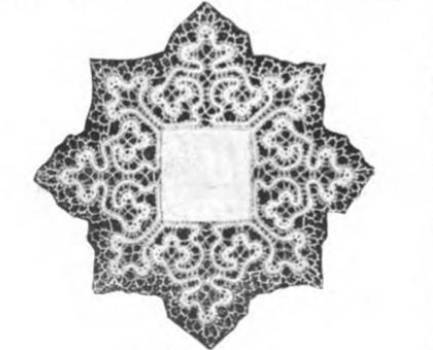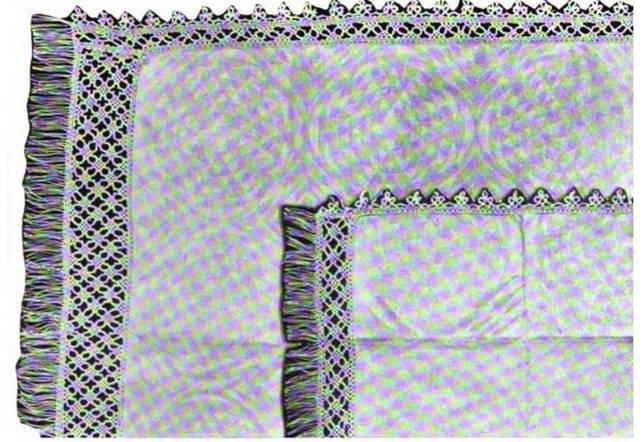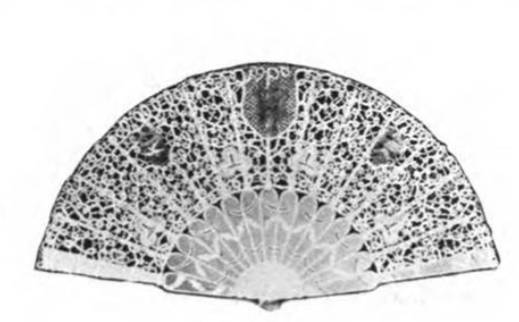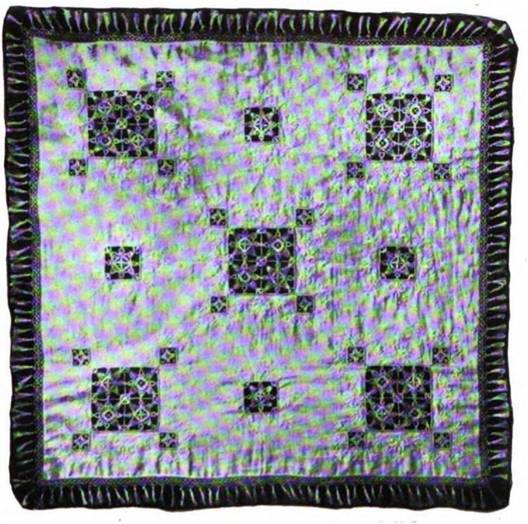|
LE MERLETTAIE DELLA
REGINA a firma di c.e. Tratto da “La Panarie”, 1931
FAGAGNA appare in
un paesaggio degno dello sfondo d'una Madonna quattrocentesca: radi pini e
cipressi sur un colle verde vellutato, in
lontananza una rocca e un campanile merlato fra poche case, la pianura
evanescente che si fonde col cielo luminoso. Saliti sul colle, non si vorrebbe
più rifar la strada del ritorno, ma incamminarsi lungo le stradicciuole
solitarie care ad Ippolito Nievo, tra acacie e prati in fiore, sfiorare le
aie e le bianche chiese vigilanti a cui fan riscontro i castelli medievali
grigi di corruccio. Paesaggio di sogno, il quale mi spiega la ragione per cui
qui prospera l’arte del merletto; la sua grazia infatti non suscita e
alimenta sentimenti gentili nelle contadinelle che vedo intente
allo sfalcio dei fieni ?
Fagagna, foto Brisighelli Un canto riga la
maestà del meriggio primaverile, passa, s'allontana: le più giovani si
rimandano da poggio a poggio i motivi delle antiche villotte. A tratti
giungono voci di campane e trilli di uccelli dalle macchie: quasi un richiamo
di suoni, il quale spiega ancora il fiorire di un'arte che si rivela persino
dalle finestre delle case rustiche, ingentilite, oltre le viti che
s'arrampicano sopra gli archi dei sottoportici, di tende ricamate. Le
osservo: son proprio tende bordate di merletti; nel centro d’ognuna traspare
un motivo di fiori e di foglie; merletti veri, di quelli che usano soltanto
le dame nelle loro dimore lussuose. Una popolana appaga
con semplicità la mia meraviglia; ogni casa a Fagagna
è fornita di merletti; ogni ragazza che sposa ne reca con sé, come nel tempo
in cui la vita scorreva più lenta e più pia, e le mani muliebri traevano dal
filo e dall'ago miracoli aracnei. Alla messa della domenica a Fagagna le donne han quasi tutte sul capo dei veli
ricamati; e la domenica i giovinotti recan tutti nel taschino della giacca un fazzolettino con
un ricamo sull'orlo e due iniziali intrecciate in un angolo. Raggiungo il paese
sostando dinanzi alle case: c’è una Madonnina, sur
un muro, anch'essa col suo bravo ricamo sopra lo sporto della nicchia, che
sembra una minuscola mensa d'altare. Ecco, in piazza, un
edilizio dai muri senza intonaco, severo e gaio ad un tempo: la” Casa della
gioventù”, la magnifica istituzione dovuta alla filantropia di pochi generosi
e cresciuta via via per l'amore di pochissimi. In
questa casa, accanto a un asilo e a una scuola per i piccoli, ha sede la
Scuola di merletti a tombolo. Accompagnato da una suora, attraverso stanze
serene, il cortile verde di piante e garrulo di bimbi; entro in una sala, al
primo piano dell'ala sinistra del fabbricato, ove scorgo le allieve intente al lavoro; tra esse un’altra suora insegna e
sorveglia. Osservo il lavoro che esce dalle dita instancabili di queste
contadinelle, le quali a mezzodì han forse lasciato i campi per correr qui a
creare meravigliosi merletti. Han dieci, dodici, quindici anni; quando piove,
e sono libere dai lavori campestri, capitano anche le mamme e persino le
nonne; tre generazioni curve al tombolo, a rifare lo stesso giuoco dei
fuselli saltellanti tra la siepe d'innumerevoli spilli che punteggiano il
disegno. E l’ordito procede di pochi millimetri al giorno, con diligenza e
pazienza claustrali.
Particolare
dell’aula con le giovani merlettaie
Giovane merlettaia,
foto Brisighelli Una suora mi spiega
sottovoce : — Qualcuna - e
accenna alle piccole merlettaie - ha atteso oltre un anno al medesimo lavoro. — Ma è possibile la
pratica di tanta virtù, nel secolo in cui le macchine han sostituito il
lavoro dell'uomo? La suora sorride e
volge lo sguardo all’uscio, attraverso cui s'intravvede nella penombra una cappellina fragrante di rose e linda di lini. La sua
risposta vale più che le parole: quest’arte gentile non è forse una preghiera
silenziosa com’era per la cividalese Benvenuta Boiani il mirabile velo da lei offerto al Signore? E che cosi sia
m’assicura la storia della Scuola, sorta con grande fede, sorretta e risorta
con fede anche più grande. Istituita il 1° gennaio 1892 dalla contessa Cora di Brazzà Savorgnan, una gentildonna innamorata della sua nuova
patria e d'ogni eletta manifestazione d'arte, fu allogata in una stanza
concessa dal Municipio, aiutata e sussidiata dal Legato Pecile. Per sei anni visse
dipendente dall'Amministrazione Brazzà che
provvedeva filo, fuselli, campioni, disegni, e ritirava tutto il lavoro prodotto
dalle merlettaie; mentre il senatore Gabriele Luigi Pecile,
bene merito non solo di Fagagna ma del Friuli ed
entusiasta della geniale istituzione, provvedeva lo stipendio alla maestra.
Alla fine del 1898 la contessa Cora di Brazzà, dovendo recarsi in America, decise di chiudere la
Scuola dandone avviso al senalore Pecile ed esprimendo l'augurio che qualcuno ne
raccogliesse l'eredità. L'augurio si avverò nel modo più lieto: il senatore Pecile e la signorina Noemi Nigris - ai quali Fagagna deve
perenne riconoscenza - s’occuparono tosto con ardore per dare nuova vita
all’istituzione. E la Scuola inizia una vita nuova il 1° gennaio 1899: nuova
e più intensamente benefica. Sostenuta dal Legato
Pecile che pagava la maestra e il filo, dal
Municipio che concesse gratuitamente una magnifica stanza, dai privati che
davano le legna per il riscaldamento, dall'Amministrazione Brazzà che continuò a ordinare molti lavori, la Scuola
non doveva pensare che all'illuminazione, alle piccole spese di posta, di
poligrafo, dei cartoni, della carta per lucidare (carta da lucido), dividendo
il guadagno - dedotta una modesta trattenuta per le spese impreviste o
anticipate - fra le merlettaie. L’anno 1908 segna
una nuova ascensione della modesta e cara istituzione: più di sessanta
bambine frequentano la Scuola, tanto che si deve chiedere al Municipio
un'aula più vasta. I lavori eseguiti
figurano intanto in molte esposizioni in Italia e all’estero, ove ottengono le
maggiori onorificenze; si allargano e aumentano i clienti, fra i quali la
Scuola saluta con legittimo orgoglio S. M. la Regina Madre che, conosciuta la
signorina Nigris, vuol rivederla di frequente a
Roma, a Venezia, a Salsomaggiore ove raccoglie con benevola e premurosa
cortesia, dimostrandole il più vivo interessamento verso la Scuola; e fa
numerosi acquisti, commette lavori, ammira i disegni e l'esecuzione, largisce
preziosi consigli. Una volta le dice: «Se avverrà che la Scuola non abbia
lavoro, mi scriva: ho sempre tante cose da fare, le darò sempre commissioni
». La Regina Madre aveva anzi promesso di visitare Fagagna,
senonché la morte repentina le impedì di recarsi
nel grazioso paese donde provenivano i merletti a lei cari. E noti e cari i
merletti di Fagagna sono anche a S. M. la Regina
Elena, che ne ebbe in dono in occasione delle sue nozze. Fra i clienti più
notevoli van poi segnalate le «Industrie Femminili Italiane” di
cui la Scuola fa parte, le quali cooperano con ingenti ordinazioni al suo
incremento. Il successo è cosi costantemente lieto che ormai il lavoro viene
distribuito a domicilio per far fronte alle numerose e crescenti commissioni. L'accuratissima
scelta dei modelli riprodotti dall'antico, fra cui molti di carattere
friulano, e il lavoro finemente eseguito, la rendono in pochi anni rinomata
in tutta Italia; ed è sotto i più lieti auspici che si preparava nel 1917 a
festeggiare il 25° anniversario della fondazione; ma, nell'ottobre, l'invasione
disperde opere e propositi. La ripresa avviene,
nel novembre del 1918, per volontà della signorina Nigris,
alla quale guardano come a un angelo tutelare i bimbi macerati dalle
privazioni della cattività, scossi dalle emozioni dell'esodo; e la Nigris, insieme con l’Asilo e la Scuola, fa rivivere
l’industria anticipando i fondi necessari, cozzando con l'inerzia delle
operaie, con la difficoltà di provveder cartoni, carta, refe, spilli. A Udine
non c'è neppure un negozio. Tuttavia lei si rimette pazientemente a rifare i
disegni distrutti, valendosi di alcuni miseri avanzi, e a riprodurne di
nuovi; e finalmente, nella primavera del 1920, provvista anche la carta e
l’inchiostro per poligrafare i disegni, aduna amorevolmente le bambine che
frequentavano le scuole private nella «Casa della gioventù”, sotto la
direzione di una Suora di Cantù, della patria
cioè del merletto a tombolo. A poco a poco ritornano le vecchie operaie,
parecchie delle quali già madri di famiglia; e mentre si cerca di trattenere
le bambine nella Scuola per educarle e istruirle, alle spose si dà il
merletto a domicilio perché possano, pur lavorando, badare alla famiglia.
Servizio all’americana
con merletto tipico di Cantù a punto Venezia
Sottopiatto per
pesce “ Venezia” Ormai la Scuola è
rinata e procede sicura: la Presidente signorina Nigris
non solo la sorregge e sorveglia, ma - esperta nel disegno com’è - provvede
personalmente tutti i modelli e pensa allo smercio della produzione. I primi
merletti rientrano cosi nelle case friulane, spoglie di ogni cosa, a recare
il sorriso della gentilezza nelle guardarobe
predate. I prodotti riprendono, attraverso le “Industrie Femminili
Italiane” la via di Roma, di Milano,
di Torino, di Genova, donde arrivano sempre nuove e crescenti ordinazioni. II
prossimo anno la Scuola festeggerà il quarantesimo anniversario della fondazione:
e sarà festa di popolo, ché essa ormai costituisce una piccola gloria di Fagagna laboriosa, e sarà festa di riconoscente amore
verso colei che, con friulana tenacia, ha saputo alimentare l’amore per
l'arte gentile. Quante signore
conoscono la Scuola di merletti a tombolo di Fagagna?
È una domanda discreta, a cui risponderanno le lettrici gentili. Per mio
conto, dò loro un consiglio: di andarla a visitare.
Ne ritrarranno un'impressione commovente di grazia e di serenità. Aggiungo
anche di orgoglio, in quanto i preziosi merletti, al modo stesso dei fiori
cresciuti nei prati, escono dal cuore, più che dalle mani, di umili figlie
del popolo nostro.
Sottobicchiere
Tovagliati Friulani
Rocchetto donato
dalla Scuola a S. E. monsignor A. A. Rossi
Ventaglio
Tovaglietta “Layard”, ideata dalla contessa Cora Nel “Giornale di
Udine” del 06 settembre 1909 è apparso un articolo su una mostra svoltasi a Martignacco, dove si fa cenno anche della scuola merletti
della contessa Cora: “Affermo l'interesse vivissimo col quale ho assistito ai lavori di
merletto, l’industria fondata della contessa Corà
di Brazzà, della scuola di Brazza:
di bambine di appena sei e sette anni che fanno lavorucci
con una serietà e grazia che strappano i baci. L'esposizione dei merletti è
quest'anno notevolissima per la bellezza di alcuni prodotti.” _______________________________________________________________________________________________ I testi sono dell’autrice del sito frutto di una
accurata e laboriosa ricerca. E’ vietata qualsiasi forma di
riproduzione, anche parziale, di questa e di tutte le pagine del sito. Sitografia https://archive.org/details/la-panarie-1931/ https://archive.org/details/213_GiornaleUdine_06-09-1909
Friuli V.G. Cora
Slocomb di Brazzà Scuole di
merletti Home
page |